La società dello spettacolo ,Guy Debord, La società dello spettacolo, Milano, Baldini Castoldi Dalai editore, 2008, p. 53.

Le prime trentaquattro tesi sono incentrate sulla descrizione della società dello spettacolo. La prima tesi contiene uno dei tanti
détournement che caratterizzano il saggio di Debord. Essa ricalca l'incipit de
Il capitale di
Marx: «Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di
spettacoli».
[1] Le immagini del mondo dettate dalle necessità della produzione
capitalistica si sono staccate dalla vita, al punto che lo
spettacolo è considerato come "l'inversione della vita".
[1] La definizione dello spettacolo, riportata nella quarta tesi, è la seguente: «Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini», una «visione del mondo che si è oggettivata».
[2] Lo spettacolo, così come lo descrive Debord, è sia il mezzo, sia il fine del modo di produzione vigente. Non bisogna però pensare che lo spettacolo sia semplicemente irreale. Lo spettacolo inteso come inversione del reale è effettivamente realtà. In un altro
détournement(stavolta di matrice
hegeliana), Debord afferma che «la realtà sorge nello spettacolo, e lo spettacolo è reale».
[3] Chiaramente l'obiettivo dello spettacolo è quello di legittimare se stesso oltre che i rapporti sociali di produzione dei quali è guardiano, e di conseguenza si presenta in continuazione (e senza possibilità effettive di contestazioni) come un elemento intrinsecamente positivo. La spettacolarizzazione della realtà prende, in un certo senso, il posto della
religione, realizzando «l'esilio dei poteri umani in un al di là» e fungendo da guardiano del sonno dalla «società moderna incatenata», di cui è il «cattivo sogno».
[4] Mentre la religione si è imposta, nella concezione debordiana, come fonte di divieti per l'uomo, lo spettacolo mostra all'uomo ciò che egli può fare, ma, scrive ancora Debord, «il permesso si oppone assolutamente al possibile».[5] Anche il momento del non-lavoro è completamente consacrato allo spettacolo e, quindi, funzionale ai rapporti sociali di produzione, di cui lo spettacolo garantisce la conservazione. Garanzia della conservazione è anche l'isolamento delle persone le une dalle altre, ma anche l'isolamento delle masse. Il primo capitolo si chiude con la seguente tesi: «Lo spettacolo è il capitale a un tal grado di accumulazione da divenire immagine».[6]
Il ruolo della merce
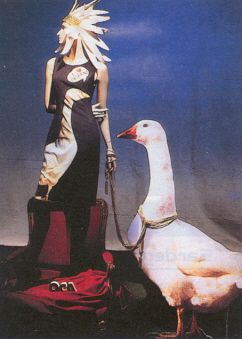
Il secondo capitolo si apre con una citazione tratta da
Storia e coscienza di classe di
György Lukács, nella quale viene analizzato il rapporto tra il lavoro e la
merce.
[7] Citando ancora il Marx de
Il capitale, la prima tesi introduce quest'ultima come una "vecchia nemica", triviale all'apparenza, ma "piena di sottigliezze metafisiche". Debord riprende esplicitamente il concetto di feticismo della merce.
[8] Essa è la portatrice di immagini per eccellenza, in quanto glorifica il capitalismo su base mondiale, anche laddove esso non ha ancora portato una sovrabbondanza di beni. Ma questa sovrabbondanza di beni non ha assolutamente, a giudizio dell'autore, liberato l'uomo dalla necessità. Anzi, gli ha imposto una nuova necessità, un obbligo: quello del consumo. Il lavoratore, prima trattato come l'ultima ruota del carro, ora viene avvolto nella bambagia e "corrotto" anche nel suo tempo di non-lavoro. Anche lo svago, attraverso il
consumismo, si trasforma in un modo per favorire l'accumulazione capitalistica e dar sfogo alla sovrabbondanza di merci, che però non ha garantito al lavoratore una vera liberazione dall'obbligo del lavoro. Anche il lavoro, come aveva già sottolineato Marx, diventa una merce. Si tratta sempre di sopravvivenza, ma
sopravvivenza aumentata,
[9] che fa del lavoratore un consumatore e del consumatore reale un "consumatore di illusioni". L'economia diventa un fine, da mezzo che era stata, ma così facendo «esce dall'
inconscio sociale che dipendeva da essa senza saperlo».
[10] L'
es diventa
io, passa allo stato cosciente e, come tale, può e deve decomporsi. La sopravvivenza del sistema è quindi legata ai risultati della
lotta di classe, che è il contrario della società dello spettacolo, in quanto società della coscienza.
[11].........................
 La "separazione" delle immagini dalla vita
La "separazione" delle immagini dalla vita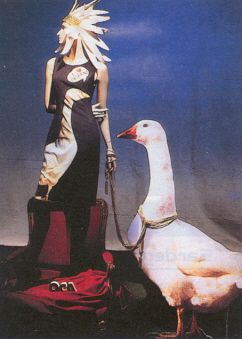 Il secondo capitolo si apre con una citazione tratta da Storia e coscienza di classe di György Lukács, nella quale viene analizzato il rapporto tra il lavoro e la merce.[7] Citando ancora il Marx de Il capitale, la prima tesi introduce quest'ultima come una "vecchia nemica", triviale all'apparenza, ma "piena di sottigliezze metafisiche". Debord riprende esplicitamente il concetto di feticismo della merce.[8] Essa è la portatrice di immagini per eccellenza, in quanto glorifica il capitalismo su base mondiale, anche laddove esso non ha ancora portato una sovrabbondanza di beni. Ma questa sovrabbondanza di beni non ha assolutamente, a giudizio dell'autore, liberato l'uomo dalla necessità. Anzi, gli ha imposto una nuova necessità, un obbligo: quello del consumo. Il lavoratore, prima trattato come l'ultima ruota del carro, ora viene avvolto nella bambagia e "corrotto" anche nel suo tempo di non-lavoro. Anche lo svago, attraverso il consumismo, si trasforma in un modo per favorire l'accumulazione capitalistica e dar sfogo alla sovrabbondanza di merci, che però non ha garantito al lavoratore una vera liberazione dall'obbligo del lavoro. Anche il lavoro, come aveva già sottolineato Marx, diventa una merce. Si tratta sempre di sopravvivenza, ma sopravvivenza aumentata,[9] che fa del lavoratore un consumatore e del consumatore reale un "consumatore di illusioni". L'economia diventa un fine, da mezzo che era stata, ma così facendo «esce dall'inconscio sociale che dipendeva da essa senza saperlo».[10] L'es diventa io, passa allo stato cosciente e, come tale, può e deve decomporsi. La sopravvivenza del sistema è quindi legata ai risultati della lotta di classe, che è il contrario della società dello spettacolo, in quanto società della coscienza.[11].........................
Il secondo capitolo si apre con una citazione tratta da Storia e coscienza di classe di György Lukács, nella quale viene analizzato il rapporto tra il lavoro e la merce.[7] Citando ancora il Marx de Il capitale, la prima tesi introduce quest'ultima come una "vecchia nemica", triviale all'apparenza, ma "piena di sottigliezze metafisiche". Debord riprende esplicitamente il concetto di feticismo della merce.[8] Essa è la portatrice di immagini per eccellenza, in quanto glorifica il capitalismo su base mondiale, anche laddove esso non ha ancora portato una sovrabbondanza di beni. Ma questa sovrabbondanza di beni non ha assolutamente, a giudizio dell'autore, liberato l'uomo dalla necessità. Anzi, gli ha imposto una nuova necessità, un obbligo: quello del consumo. Il lavoratore, prima trattato come l'ultima ruota del carro, ora viene avvolto nella bambagia e "corrotto" anche nel suo tempo di non-lavoro. Anche lo svago, attraverso il consumismo, si trasforma in un modo per favorire l'accumulazione capitalistica e dar sfogo alla sovrabbondanza di merci, che però non ha garantito al lavoratore una vera liberazione dall'obbligo del lavoro. Anche il lavoro, come aveva già sottolineato Marx, diventa una merce. Si tratta sempre di sopravvivenza, ma sopravvivenza aumentata,[9] che fa del lavoratore un consumatore e del consumatore reale un "consumatore di illusioni". L'economia diventa un fine, da mezzo che era stata, ma così facendo «esce dall'inconscio sociale che dipendeva da essa senza saperlo».[10] L'es diventa io, passa allo stato cosciente e, come tale, può e deve decomporsi. La sopravvivenza del sistema è quindi legata ai risultati della lotta di classe, che è il contrario della società dello spettacolo, in quanto società della coscienza.[11].........................
Nessun commento:
Posta un commento