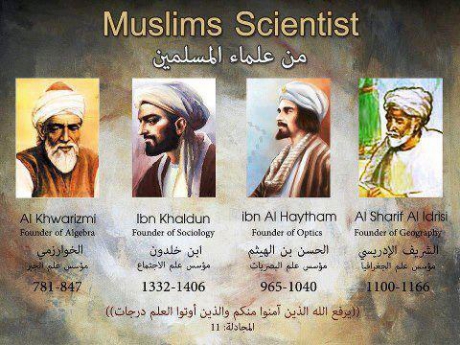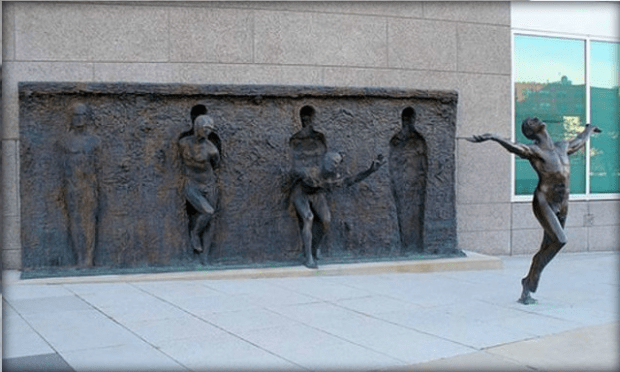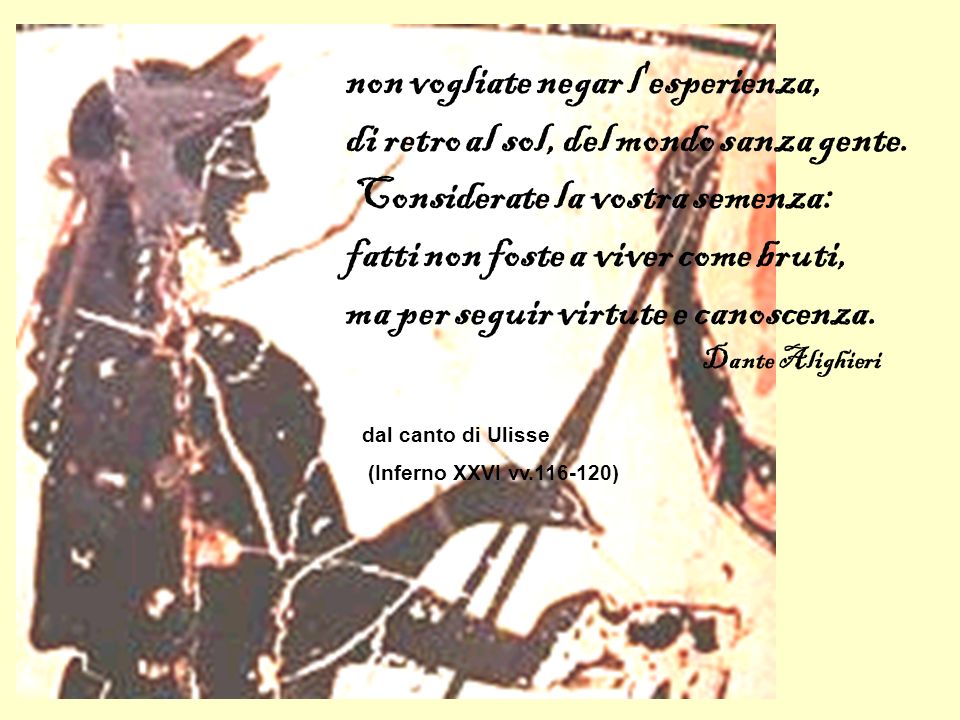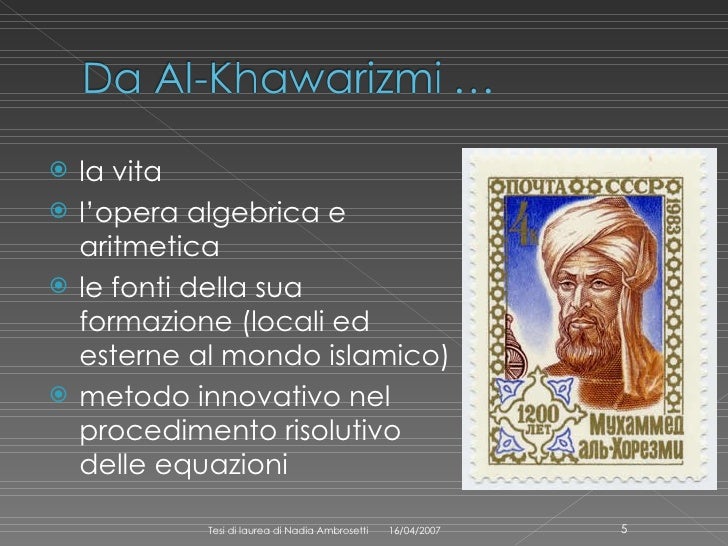..................Oggi i progressi della scienza analitica consentono di rilevare i residui di farmaci presenti nell’ambiente una volta non riconoscibili e di valutare l’eventuale eco-tossicità di molti prodotti e composti farmaceutici che penetrano nell'ambiente, anche se in quantità relativamente piccole.Le potenziali vie di ingresso nell’ambiente[2] sono l’escrezione del composto originario o dei suoi metaboliti attraverso il sistema fognario, il rilascio diretto nelle acque reflue delle officine produttive, degli ospedali o lo smaltimento tramite WC/lavandini, i depositi terrestri, ad esempio nell’impiego di fanghi, la lisciviazione di rifiuti solidi dalle discariche, o l’irrigazione con acque reflue trattate o non trattate.
L'escrezione di farmaci dopo l'uso terapeutico umano e veterinario è la porta principale d'ingresso dei farmaci nell'ambiente ed è una conseguenza inevitabile del consumo di medicinali e pertanto molto più difficile da controllare. I farmaci sono generalmente solubili in acqua e quindi finiscono negli scarichi fognari. Molte sostanze chimiche farmaceutiche non sono degradabili per resistere all'ambiente acido dello stomaco o per avere una lunga durata, e possono penetrare, persistere e diffondersi nell'ambiente, specialmente nelle acque, e ritornare, attraverso la catena alimentare, negli esseri umani................Conseguenze di inquinamento ambientale da farmaci : L'esposizione degli esseri umani e degli animali ai farmaci attraverso l'ambiente può essere diretta o indiretta[3]. Nel lungo termine gli inquinanti farmaceutici potrebbero essere responsabili di tossicità cronica e di altri effetti tra cui la resistenza microbica, alterazioni del sistema endocrino, inibizione della crescita, distruzione degli ecosistemi microbici, citotossicità, mutagenicità, e teratogenicità. Anche se non esiste uno studio sistematico che provi un pericolo determinato o la tossicità da farmaci presenti nell’ambiente per l'uomo, gli effetti potenziali sulle fauna selvatica sono stati ampiamente dimostrati. Un esempio è la drastica riduzione del numero di avvoltoi nel subcontinente indiano dovuto alla loro esposizione indiretta a diclofenac. Uno studio in Pakistan ha rivelato che gli avvoltoi subiscono gravi danni renali dal consumo delle carcasse di bestiame trattate con questo farmaco. In un periodo di tempo relativamente breve, il numero di avvoltoi è diminuito così drasticamente da renderli una specie in via di estinzione. Un altro esempio è la sterilità delle rane attribuita a tracce di pillole contraccettive orali nelle acque. L'ivermectina, usata come antielmintico nella pratica veterinaria, eliminata attraverso le feci, reca danno a organismi come lo scarabeo stercorario. La presenza di ormoni sessuali femminili (etinilestradiolo) nell’ambiente acquatico sembra provochi mutazioni sessuali nei pesci. È ipotizzabile che gli esseri umani, che sono in cima alla catena alimentare, possano essere interessati dagli inquinanti farmaceutici ambientali. Tuttavia, per dimostrarlo sono necessarie ulteriori ricerche.
“Il pericolo principale è la resistenza microbica – scrivono Bikash Medhi and Rakesh K. Sewal, due farmacologi indiani dell’Institute of Medical Education and Research di Chandigarh, in un editoriale pubblicato sull’Indian Journal of Farmacology – L'esposizione continua a basse dosi di antibiotici attraverso l'acqua potabile potrebbe condurre infatti a forme di resistenza. Il minore interesse delle case farmaceutiche per lo sviluppo di nuovi antimicrobici a favore di farmaci "lifestyle" potrebbe aggravare il problema. Anche se l'effetto di dosi molto basse di farmaci nell'ambiente non è chiaro, popolazioni particolari come le donne incinte, i bambini, la popolazione geriatrica, le persone con insufficienze renali o epatiche potrebbero essere esposte a un maggiore rischio, perché in queste categorie la farmacocinetica è alterata e anche dosi minime possono rivelarsi tossiche. Allo stesso modo, alcuni farmaci in micro dosi potrebbero evidenziare azioni sinergiche”.
Gli approcci di EPV comprendono la progettazione di farmaci verdi, la chimica verde (o sostenibile), lo sviluppo di prodotti biodegradabili, la minimizzazione delle emissioni industriali, l'educazione all'uso razionale dei farmaci, il miglioramento delle pratiche di prescrizione, gestione e smaltimento dei farmaci inutilizzati. Questi nuovi approcci sono stati introdotti nel monitoraggio ambientale di antidepressivi, antibatterici come flourochinolonici, ormoni, paracetamolo e diclofenac.
A causa della complessità dell’esposizione dell'ambiente ai farmaci e del loro specifico effetto biochimico, per migliorare la comprensione scientifica del fenomeno sono necessarie ulteriori ricerche, che comprendono il monitoraggio biologico di specie diverse, la misurazione, la previsione e l'identificazione dei potenziali effetti delle sostanze inquinanti. La Commissione europea (CE) valuta i dati relativi alla presenza di farmaci nell'ambiente e il potenziale impatto sull'ecosistema e sulla salute pubblica, in modo da garantire un costante aggiornamento della normativa vigente per i farmaci umani e veterinari. L'industria, il mondo accademico e i governi sono stati incoraggiati a condurre studi in partnership per verificare che l'orientamento EPV stia offrendo livelli adeguati di tutela ambientale e alcune aziende farmaceutiche dell'Unione europea hanno utilizzato i piani di gestione del rischio ambientale (ERMPs) come risorsa per la valutazione e la gestione dei rischi ambientali di un farmaco durante tutto il suo ciclo di vita. I piani includono informazioni di chimica-fisica, sul metabolismo umano, la farmacocinetica, la tossicologia preclinica e l'impatto ambientale del principio attivo e degli eccipienti del farmaco. L’ERMP deve essere aggiornato qualora vengano identificati eventuali rischi ambientali nuovi o emergenti. Le ricerche accademiche stanno rapidamente progredendo e di recente la Società di Tossicologia e Chimica Ambientale (SETAC) ha pubblicato i risultati di un laboratorio collaborativo che ha individuato le prime grandi questioni relative all'impatto dei prodotti farmaceutici sull'ambiente e ha definito le aree in cui indirizzare la ricerca futura.
Sulla base di questi progressi teorici essenziali, sono state introdotte in Occidente alcune disposizioni obbligatorie ispirate ai principi di EPV. L'Unione Europea ha prodotto una serie di interventi legislativi e di progetti di orientamento normativo in materia di EPV, tra cui il KNAPPE ("Knowledge and need assessment on pharmaceutical product in environmental waters”), che hanno valutato i rischi ambientali associati agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, ai betabloccanti, agli antibiotici e ai farmaci citotossici. Tra tutti i progetti sull’EPV, l’ERA[4] (Environmental risk assessment), che è per definizione una valutazione predittiva dei rischi normalmente basata su studi sperimentali di laboratorio, è un sistema riconosciuto come fondamentale per attuare strategie volte a minimizzare l'eventuale impatto ambientale dei prodotti farmaceutici. Sia in Europa che in Nord America, tale tipo di valutazione è obbligatoria prima del lancio di nuovi medicinali, e i regolamenti ERA europei sono attualmente i più esigenti. i risultati della valutazione condotta dall'azienda che sviluppa il farmaco vengono sottoposti all'Agenzia Europea dei Medicinali insieme ai dati di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti a supporto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio con procedura centralizzata.
La valutazione di rischio ambientale viene condotta con un approccio a stadi, che prende il via con un iniziale screening (fase I), volto a identificare l'esposizione ambientale dei farmaci sulla base del loro potenziale di bioaccumulo e persistenza nell'ambiente. Se, a seguito della valutazione preliminare, risulta un'esposizione significativa, o se vengono identificati rischi particolari per via di specifiche caratteristiche del composto, si rende necessaria la conduzione di ulteriori studi (fase II). I test di fase II identificano i potenziali effetti dei farmaci sull'ambiente e su organismi rappresentativi (ad esempio i pesci o le dafnie per l'ambiente acquatico). A tale scopo, varie metodologie di prova ampiamente riconosciute (previste principalmente dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE) costituiscono la base del processo di valutazione dei rischi, che può essere ulteriormente esteso, se necessario, caso per caso.
Il quoziente di rischio (RQ) utilizzato per le valutazioni EPV in Occidente (anche per l'ERA) è il rapporto tra la concentrazione ambientale prevista (PEC) e la concentrazione prevista priva di effetti (PNEC). Il PEC fornisce una stima della concentrazione massima di prodotto prevista in base alle proprietà fisico-chimiche e al volume annuale di utilizzo (l'uso e la successiva escrezione nel sistema delle acque reflue). Il PNEC deriva da test ecotossicologici condotti normalmente su alghe, dafnie e pesci (che rappresentano tre livelli trofici); combinati con un fattore di valutazione che rappresenta l'incertezza derivante dalle differenze di tossicità tra specie e all'interno della stessa specie.
Se RQ < 1 il farmaco testato ha un rischio ambientale trascurabile e quindi può essere impiegato. Se RQ = 1 (ovvero, PEC = PNEC), potrebbero verificarsi effetti ambientali collaterali. In questo caso si può intervenire affinando la valutazione, limitando l'utilizzo (per ridurre il PEC) o non utilizzando la sostanza. Al contrario, se RQ > 1 sarà necessario ridurre l’impiego fino a quando il PEC sarà inferiore al PNEC o non utilizzare il prodotto.
L'uso di farmaci è divenuto inevitabile nella nostra vita, ma non è indispensabile scendere a compromessi con l'equilibrio dell'ecosistema. Proteggere il pianeta dagli effetti negativi di queste sostanze è possibile. Dall'evoluzione della medicina personalizzata e dai progressi della biofarmaceutica, ad esempio, si attendono farmaci a ridotto impatto ambientale.
Un aspetto fondamentale è l'educazione all'uso razionale e consapevole del farmaco, che l'AIFA promuove direttamente e attraverso partnership.
Un aspetto fondamentale è l'educazione all'uso razionale e consapevole del farmaco, che l'AIFA promuove direttamente e attraverso partnership.
La valutazione del rischio ambientale (ERA), come detto, è divenuta obbligatoria per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci nell’Unione Europea. I risultati di tali valutazioni sono influenzati però da diversi fattori come le dosi, il metabolismo, la biodegradabilità, la concentrazione ambientale e l'ecotossicità del farmaco. È anche difficile, sulla base di studi di tossicità acuta, prevedere il potenziale pericolo cronico di un medicinale in concentrazioni sub-acute.
Per tale ragione esistono margini per l'elaborazioni di modelli più complessi ed efficaci in grado di ridurre l'incertezza relativa all'impatto ambientale dei farmaci e alla loro ecotossicità. L'Italia sta fornendo un contributo fondamentale all'elaborazione di questi algoritmi. L'Agenzia sta infatti studiando un progetto innovativo attraverso cui si cerca di simulare quale sarà l’impatto ambientale, ovvero la tossicità acquatica dei composti. L’efficacia di tali modelli, insieme a una crescente trasparenza e al miglioramento nella gestione dei farmaci inutilizzati e scaduti, rappresentano sfide fondamentali per il futuro del pianeta.
[1] Si stima che ogni anno vengano consumate 100.000 tonnellate di antibiotici. Più di 30 miliardi di dosi di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) ogni anno solo negli Stati Uniti.Ecopharmacovigilance: An issue urgently to be addressed
Cari lettori,
come avrete notato non sono un amante degli editoriali. Tuttavia il Natale è un buon motivo e mi fa piacere inviarvi i più calorosi auguri. Un altro motivo per me di grande interesse è quello di farvi conoscere la Ecofarmacologia. L 'ecofarmacologia è una "disciplina" di recente interesse che unisce due mondi molto diversi: il mondo dei farmaci e il mondo ecologico. Vi potreste domandare perchè tutto ciò. Personalmente ho un forte interesse verso l'ambiente, d'alta parte mi occupo di farmaci, in particolare dal punto di vista del loro profilo di sicurezza, da molto tempo. L'ecofarmacologia riguarda la "vita del farmaco" nell'ambiente (ecosistema) con tutte le eventuali conseguenze sulle specie animali, uomo in prima linea. Si valuta che all'anno approssimativamente 100mila tonnellate di prodotti farmaceutici siano venduti in tutto il mondo. Sono cifre da capogiro. I farmaci vengono eliminati dall'organismo, anche metabolizzati, e finiscono perciò nell'ambiente attraverso gli scarichi inquinando fiumi e suolo dove possono restare anche per anni e anni. Le eventuali conseguenze che ne possono derivare per la salute dell'uomo sono evidenti. Dovremo perciò avere sempre più interesse per i rischi ambientali che dipendono dall'impiego di farmaci su larga scala. Perdipiù l'uso dei farmaci è in continua crescita, essendo il farmaco considerato quasi alla stregua di un "bene di consumo". Essi possono raggiungere i corsi d'acqua, i laghi e i mari. Vi sono dati interessanti sui rischi che estradiolo e etinilestradiolo possono causare sull' ambiente acquatico. La ricerca in questo settore oggi è orientata in particolare sui pesci mentre sull'uomo non si conosce pressochè nulla.
Quel che dico non deve allarmarvi ma piuttosto farvi pensare. L'uomo potrebbe assumere quantitativi minimi di farmaci, senza saperlo e non necessari, con un'eventuale compromissione della risposta ad essi e con rischi non previsti. Nel caso degli antibiotici la resistenza batterica può essere un fatto da non sottovalutare. Ricordo che il governo svedese ha richiesto all' Agenzia Nazionale sui Farmaci di stendere un documento ufficiale sull'impatto ambientale dei farmaci più utilizzati in quel paese. Inoltre nella Direttiva 2004/27/CE del Consiglio si legge che la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano comporterà una valutazione dei suoi rischi per l'ambiente.
C'è molto su cui riflettere e molto da fare. E' un mondo nel quale nuotiamo e del quale conosciamo ben poco!
come avrete notato non sono un amante degli editoriali. Tuttavia il Natale è un buon motivo e mi fa piacere inviarvi i più calorosi auguri. Un altro motivo per me di grande interesse è quello di farvi conoscere la Ecofarmacologia. L 'ecofarmacologia è una "disciplina" di recente interesse che unisce due mondi molto diversi: il mondo dei farmaci e il mondo ecologico. Vi potreste domandare perchè tutto ciò. Personalmente ho un forte interesse verso l'ambiente, d'alta parte mi occupo di farmaci, in particolare dal punto di vista del loro profilo di sicurezza, da molto tempo. L'ecofarmacologia riguarda la "vita del farmaco" nell'ambiente (ecosistema) con tutte le eventuali conseguenze sulle specie animali, uomo in prima linea. Si valuta che all'anno approssimativamente 100mila tonnellate di prodotti farmaceutici siano venduti in tutto il mondo. Sono cifre da capogiro. I farmaci vengono eliminati dall'organismo, anche metabolizzati, e finiscono perciò nell'ambiente attraverso gli scarichi inquinando fiumi e suolo dove possono restare anche per anni e anni. Le eventuali conseguenze che ne possono derivare per la salute dell'uomo sono evidenti. Dovremo perciò avere sempre più interesse per i rischi ambientali che dipendono dall'impiego di farmaci su larga scala. Perdipiù l'uso dei farmaci è in continua crescita, essendo il farmaco considerato quasi alla stregua di un "bene di consumo". Essi possono raggiungere i corsi d'acqua, i laghi e i mari. Vi sono dati interessanti sui rischi che estradiolo e etinilestradiolo possono causare sull' ambiente acquatico. La ricerca in questo settore oggi è orientata in particolare sui pesci mentre sull'uomo non si conosce pressochè nulla.
Quel che dico non deve allarmarvi ma piuttosto farvi pensare. L'uomo potrebbe assumere quantitativi minimi di farmaci, senza saperlo e non necessari, con un'eventuale compromissione della risposta ad essi e con rischi non previsti. Nel caso degli antibiotici la resistenza batterica può essere un fatto da non sottovalutare. Ricordo che il governo svedese ha richiesto all' Agenzia Nazionale sui Farmaci di stendere un documento ufficiale sull'impatto ambientale dei farmaci più utilizzati in quel paese. Inoltre nella Direttiva 2004/27/CE del Consiglio si legge che la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano comporterà una valutazione dei suoi rischi per l'ambiente.
C'è molto su cui riflettere e molto da fare. E' un mondo nel quale nuotiamo e del quale conosciamo ben poco!
Giampaolo Velo