domenica 6 gennaio 2013
MILLENIALS , A PORTRAIT OF GENERATION NEXT
da Generation y , Wikipedia
Demographics In the United States the actual "Echo Boom" was a thirteen year span between 1982 and 1995[39] when for the first time since 1964, the number of live births reached over four million.[citation needed] It wouldn’t be until 1985 that the live birth number would even match that of 1965 at 3.760 million.[citation needed] Also it should be noted that the birthrate of 1971’s 17.2% has yet to be reached according to the 2000 census.[40][41] The majority of Generation Y is culturally liberal[42] with many respecting same-sex marriage rights to the LGBT community[43] among other politically liberal stances, but, in spite of the new dominant liberal growth, new youth clubs and groups have been created in developed countries (such as the US, UK, Japan, Australia and Italy) to take the task of promoting and preserving conservative views and beliefs.[citation needed][44] One analysis of American demographics locates the increase in births between 1978 and 1994. By this calculation there are 60 million members of the generation,[45] just shy of the 78.2 million baby boomers (as of 2005).[46] Generation Y'ers are largely the children of the Baby Boomers. Younger members of this generation have parents that belong to Generation X. Religion "The Spirit of Generation Y", a 2006 Australian study, found 48% of those polled believed in a God, while 20% did not believe in a God and 32% were unsure if a God exists.[47] A 2005 American study looked at 1,385 people aged 18 to 25 and found that over half of those in the study said that they pray regularly before a meal. A third said that they talked about religion with friends, attend places of worship, and read religious materials weekly. 23% of those studied did not identify themselves as belonging to a religious denomination. [48] A recent poll by the Pew Research Center on religion and Generation Y showed that 64% of Americans in this generation believe in God. [49] Peter Pan Generation This generation is also sometimes referred to as the Boomerang Generation or Peter Pan Generation because of their perceived penchant for delaying some of the rites of passage into adulthood longer than most generations before them, and because of a trend toward living with their parents for longer than recent generations.[50] The primary cause of this increased trend can be defined in economic terms.[51] Economic crises, including the dot-com bubble in 2000, and the United States housing bubble that led to the current financial crisis have made paying market-level rent, or any rent, difficult for a generation riddled with high unemployment levels.[52] However, economics is not the only explanation. Questions regarding a clear definition of what it means to be an adult also impacts a debate about delayed transitions into adulthood. For instance, one study by professors at Brigham Young University found that college students are more likely now to define "adult" based on certain personal abilities and characteristics rather than more traditional "rite of passage" events.[53] Dr. Larry Nelson, one of the three Marriage, Family, and Human Development professors to perform the study, also noted that some Millennials are delaying the transition from childhood to adulthood as a response to mistakes made by their parents. "In prior generations, you get married and you start a career and you do that immediately. What young people today are seeing is that approach has led to divorces, to people unhappy with their careers. The majority want to get married--they just want to do it right the first time, the same thing with their careers." [53] Communication and interaction The Millennial Generation, like other generations, has been shaped by the events, leaders, developments and trends of its time.[54] The rise of instant communication technologies made possible through use of the internet, such as email, texting, and IM and new media used through websites like YouTube and social networking sites like Facebook, Myspace, and Twitter, may explain the Millennials' reputation for being somewhat peer-oriented due to easier facilitation of communication through technology.[55] Expression and acceptance has been highly important to this generation. In China, with a total population of a billion people, the urge to stand out and be individualistic has become a staple of the Chinese youth culture[56]. Elsewhere, mainly in more well-developed nations, several cohorts of Generation Y members have found comfort in online gaming such as through MMORPGs and virtual worlds like World of Warcraft and Second Life[57]. Flash mobbing, internet meme, and online communities have given some of the more expressive Generation Y members acceptance, while online pen pals have given the more socially timid individuals acceptance as well[58]. Digital technology In their 2007 book, Junco and Mastrodicasa expanded on the work of Howe and Strauss to include research-based information about the personality profiles of Millennials, especially as it relates to higher education. They conducted a large-sample (7,705) research study of college students. They found that Next Generation college students were frequently in touch with their parents and they used technology at higher rates than people from other generations. In their survey, they found that 97% of students owned a computer, 94% owned a cell phone, and 56% owned a MP3 player. They also found that students spoke with their parents an average of 1.5 times a day about a wide range of topics.[59] Other findings in the Junco and Mastrodicasa survey included that 76% of students used instant messaging, 92% of those reported multitasking while IMing, and 40% of students used television to get most of their news and 34% the Internet. In June 2009, Nielsen released the report, "How Teens Use Media" which discussed the latest data on media usage by generation. In this report, Nielsen set out to redefine the dialogue around media usage by the youngest of Generation Y, extending through working age Generation Y and compared to Generation X and Baby Boomers.[60] Pop culture The Millennials grew up amidst a time during which the internet caused great change to all traditional media. Shawn Fanning, a Generation Y member, founded the peer to peer file sharing service Napster while in college. Though the RIAA won a lawsuit and shut down the service in 2001, as a result of these innovations in technology the Millennials had access to more music on demand than any previous generation, and have forced the recording industry to adapt to new business models. Literature and pop culture of the 1990s and 2000s popular with Gen Y include Goosebumps (childhood)[61], Harry Potter, The Lord of the Rings film trilogy and numerous fan fiction pieces to popular franchises to name a few[62]. In some ways, the Millennials have become seen as the ultimate rejection of the counterculture that began in the 1960s and persisted in the subsequent decades through the 1990s.[63][64] This is further documented in Strauss & Howe's book titled Millennials Rising: The Next Great Generation, which describes the Millennial generation as Civic Minded, rejecting the attitudes of the Baby Boomers and Generation X.[65] Kurt Andersen, the prize winning contributor to Vanity Fair writes in his book Reset: How This Crisis Can Restore Our Values and Renew America writes that many among the Millennial Generation view the 2008 election of Barack Obama as uniquely theirs, and he writes about this generational consensus building as being more healthy and useful than the counterculture protests of the late 1960s and early 1970s, going as far to say that if Millennials can "keep their sense of entitlement in check, they might just turn out to be the next Greatest Generation".[66] However due to the Global financial crisis of 2008-2009 this generation is also beginning to be compared to the Lost Generation of the late 19th and early 20th century.[67] Workforce Economic prospects for the Millennials have worsened due to the Late-2000s recession. Several governments have instituted major youth employment schemes out of fear of social unrest such as the 2008 Greek riots due to the dramatically increased rates of youth unemployment.[68] In Europe youth unemployment levels are very high (40% in Spain, 35% in the Baltic states, 19.1% in Britain[69] and more than 20% in many more) In 2009 leading commentators began to worry about the long term social and economic effects of the unemployment.[70] Unemployment levels in other areas of the world are also high, with the youth unemployment rate in the U.S. reaching a record level (18.5%, July 2009) since the statistic started being gathered in 1948.[71] In Canada, unemployment amongst youths aged 15 to 24 years of age in July 2009 was 15.9%, the highest it had been in 11 years.[72] Generation Y who grew up in Asian countries show different preferences and expectations of work to those who grew up in the US or Europe. This is usually attributed to the differing cultural and economic conditions experienced while growing up.[73] The Millennials are sometimes called the "Trophy Generation", or "Trophy Kids,"[74] a term that reflects the trend in competitive sports, as well as many other aspects of life, where "no one loses" and everyone gets a "Thanks for Participating" trophy and symbolizing a perceived sense of entitlement. It has been reported that this is an issue in corporate environments.[74] Some employers are concerned that Millennials have too great expectations from the workplace and desire to shape their jobs to fit their lives rather than adapt their lives to the workplace.[75] To better understand this mindset, many large firms are currently studying this conflict and are trying to devise new programs to help older employees understand Millennials, while at the same time making Millennials more comfortable. For example, Goldman Sachs conducts training programs that use actors to portray Millennials who assertively seek more feedback, responsibility, and involvement in decision making. After the performance, employees discuss and debate the generational differences they have seen played out.[74]
perche' sono nate le "scienze umane"
Daniel LittleaUnderstandingSociety
Nomenclature isn't everything -- but it is important nonetheless. What we call the areas of research that examine history, action, and social life makes a difference to how we carry out those inquiries. The label "social science" itself is not a neutral one. And alternatives like "behavioral science" have even more baggage.
The phrase that was favored in nineteenth century German philosophy for these areas of research was "human sciences" (Geisteswissenschaften), the term used by thinkers like Dilthey and Windelband. And French thinkers like Bourdieu and Foucault used the synonym, "les sciences humaines." (Here is an earlier post on Dilthey; link. And here is a good article on Dilthey in the SEP;link.)
Here is a formulation provided by Dilthey in Introduction to the Human Sciences: An Attempt to Lay a Foundation for the Study of Society and History in 1883:
A second important characteristic of the human sciences is the importance of history. Human beings have histories, and they make histories; and history consists of a fabric of meaningful human actions. At a larger scale, thinkers like Dilthey believed that larger historical movements and outcomes were meaningful as well; so history requires interpretation (link). And attention to history pervades the research and choice of topics of practitioners of the human sciences. As Yvonne Sherratt puts the point in Continental Philosophy of Social Science, "continental philosophy is usually a text-centred, historically sensitive tradition" (2).
A third characteristic is the importance of the skills of the humanist scholar within the exercise of the human sciences. "Science" and"humanities" are not sharply separated when it comes to understanding human affairs. Interpretation is one of the core activities of the humanities -- the interpretation of literature, art, or symbols -- and these facilities are equally valuable when it comes to interpreting actions, symbolic rituals, and history. Sherratt emphasizes the centrality of the methods and sensibilities of the humanities in the continental tradition of thinking about the social world. Here is a particularly interesting observation about the humanist roots of the continental tradition of thinking about the social sciences:
Philosophers and historians in the German tradition continue to favor the approach identified as the "human sciences" methodology, including Gadamer and Husserl. I would also put Ricoeur, Foucault, and Bourdieu within the general scope of this approach. And Sherratt also includes the critical theorists of the Frankfurt School within this tradition as well.
Thursday, January 3, 2013
The human sciences
The phrase that was favored in nineteenth century German philosophy for these areas of research was "human sciences" (Geisteswissenschaften), the term used by thinkers like Dilthey and Windelband. And French thinkers like Bourdieu and Foucault used the synonym, "les sciences humaines." (Here is an earlier post on Dilthey; link. And here is a good article on Dilthey in the SEP;link.)
Here is a formulation provided by Dilthey in Introduction to the Human Sciences: An Attempt to Lay a Foundation for the Study of Society and History in 1883:
Since Bacon's famous work, treatises which discuss the foundation and method of the natural sciences and thus serve as introductions to their study have been written for the most part by natural scientists. The most famous of those treatises is by Sir John Herschel. It seems necessary to provide a similar service for those who work in history, politics, jurisprudence, or political economy, theology, literature, or art. Those who dedicate themselves to these sciences usually get involved in them because of practical requirements of society, which wants to supply occupational training to equip leaders of society with knowledge necessary to do their work. But this occupational training will enable an individual to achieve outstanding success only to the extent that it goes beyond mere technical training. One can compare society to a great machine workshop kept in operation by the services of countless persons. One who is trained in the isolated technology of a single occupation among those activities, no matter how thoroughly he has mastered his trade, is in the position of a laborer who works away his entire life in one solitary phase of this industry: he has no idea of the forces which set the industry in motion, no conception of its other parts or their contributions to the purpose of the whole enterprise. He is the servile instrument of the society, not its consciously cooperative organ. (77)So what is involved in the concept of the human sciences? Most centrally, the idea was that there was a fundamental difference between the sciences of nature and the sciences of human action and interaction, because the former had to so with causation whereas the latter had to do with the interpretation of meaning. The human sciences were thought to be interpretive or hermeneutic at their core. A key task for the systematic study of human affairs was to make sense of the actions and expressions of the people involved. We understand a social fact when we understand the intentions, meanings, and self-understandings of the people involved. The tradition of the "human sciences" brings along with it the ideas of hermeneutics, verstehen, and critical theory.
A second important characteristic of the human sciences is the importance of history. Human beings have histories, and they make histories; and history consists of a fabric of meaningful human actions. At a larger scale, thinkers like Dilthey believed that larger historical movements and outcomes were meaningful as well; so history requires interpretation (link). And attention to history pervades the research and choice of topics of practitioners of the human sciences. As Yvonne Sherratt puts the point in Continental Philosophy of Social Science, "continental philosophy is usually a text-centred, historically sensitive tradition" (2).
A third characteristic is the importance of the skills of the humanist scholar within the exercise of the human sciences. "Science" and"humanities" are not sharply separated when it comes to understanding human affairs. Interpretation is one of the core activities of the humanities -- the interpretation of literature, art, or symbols -- and these facilities are equally valuable when it comes to interpreting actions, symbolic rituals, and history. Sherratt emphasizes the centrality of the methods and sensibilities of the humanities in the continental tradition of thinking about the social world. Here is a particularly interesting observation about the humanist roots of the continental tradition of thinking about the social sciences:
Continental schools have their own canon of thinkers, pose their own questions, set their own agendas and have a rich, deep history stemming back to Ancient Greece, Rome and early Christendom. In fact, it is this connection to its Ancient past, let us say, its humanism, that defines the continental schools of thought apart from Anglo-American philosophy of social science. ... My contention is that continental philosophy of social science is best understood as emergent from humanism. (2)
Finally, the approach taken by advocates of the "human sciences" is decidedly anti-positivist. These social thinkers are not looking for general laws of human behavior; they are not concerned to identify a non-theoretical range of empirical data that would confirm or disconfirm their assertions; and they are not interested in "falsifiability" of hypotheses and theories. The hypothetico-deductive method of confirmation and explanation has no appeal to this tradition. Likewise, this tradition is not particularly receptive to quantitative studies of social behavior; researchers in this tradition are not likely to provide statistical generalizations about a range of social phenomena. This doesn't mean that research efforts in the human sciences are not based on evidence and argument; but rather that what counts as evidence for an interpretation has as much to do with the overall plausibility of the reading as a particular range of empirical observations.
Philosophers and historians in the German tradition continue to favor the approach identified as the "human sciences" methodology, including Gadamer and Husserl. I would also put Ricoeur, Foucault, and Bourdieu within the general scope of this approach. And Sherratt also includes the critical theorists of the Frankfurt School within this tradition as well.
Disoccupazione come disagio e opportunità.
orso castano : problema cruciale quello della tecnologia e del lavoro. Martini e Gerardi provano a sfatare l'assioma "piu' tecnologia = meno lavoro" , assioma fatto proprio anche da Marx. Ragionando sul piano dei bisogni umani , rilevano che questi sono molteplici e mutevoli e che e' impossibile prevederne l'evoluzione , e questo garantirebbe un continuo bisogno di nuovo lavoro e nuove forme di lavoro. Il ragionamento presenta aspetti complessi, perche' questi nuovi bisogni potrebbero essere falsi bisogni, bisogni superflui creati per una concezione dell'uomo come plasmabile da bisogni superflui in cui si identifica per far sopravvivere il sistema e non creare laceranti contraddizioni tra ricchi e poveri, occupati e non occupati. Ma e' anche vero che, come ad esempio nel campo della comunicazione, stiamo assistendo ad una sempre rinnovata ed innovativa modalita' nel comunicare attraverso lìuso di strumenti che rendono e renderanno sempre piu' il mondo un villaggio globale mettendo in condizione di superare distanze enormi in tempo reale ed avvicinando sempre piu' le persone. Problema quindi complesso su cui molte riflesioni andranno fatte in futuro.
 Martini: Di fronte alla disoccupazione oggi il disagio è duplice: c’è ovviamente il disagio di chi è disoccupato, un disagio pesante perché – come già diceva san Tommaso – se uno non può dimostrare chi è nell’azione perde quasi la fiducia in se stesso, e c’è anche un disagio "collettivo", il non sapere che cosa fare nei confronti della disoccupazione, il disagio che nasce da una rassegnazione che bisogna combattere. È la rassegnazione dello sviluppo senza occupazione, secondo la quale lo studente, per quanto studi, è comunque condannato alla disoccupazione. Ed è preoccupante vedere quanto questa idea stia diventando un luogo comune; è oltretutto un’idea falsa, che lascia intravedere non tanto un’analisi della situazione quanto un atteggiamento dell’uomo nei confronti di un dramma. L’uomo che non è capace di affrontare un dramma si rassegna convincendosi che non c’è niente da fare.
Martini: Di fronte alla disoccupazione oggi il disagio è duplice: c’è ovviamente il disagio di chi è disoccupato, un disagio pesante perché – come già diceva san Tommaso – se uno non può dimostrare chi è nell’azione perde quasi la fiducia in se stesso, e c’è anche un disagio "collettivo", il non sapere che cosa fare nei confronti della disoccupazione, il disagio che nasce da una rassegnazione che bisogna combattere. È la rassegnazione dello sviluppo senza occupazione, secondo la quale lo studente, per quanto studi, è comunque condannato alla disoccupazione. Ed è preoccupante vedere quanto questa idea stia diventando un luogo comune; è oltretutto un’idea falsa, che lascia intravedere non tanto un’analisi della situazione quanto un atteggiamento dell’uomo nei confronti di un dramma. L’uomo che non è capace di affrontare un dramma si rassegna convincendosi che non c’è niente da fare.Perché è falsa l’idea che siamo condannati allo sviluppo senza occupazione? Su che presupposti si basa questa affermazione? Si basa su un ragionamento di questo tipo: siccome la tecnologia cambia in modo sempre più accelerato e consente di produrre le cose che producevamo prima con meno lavoro rispetto a prima, dobbiamo rassegnarci a produrre senza che l’occupazione si sviluppi. Questa idea si accompagna ad una pseudo-informazione statistica secondo la quale le grandi imprese in Italia da dieci anni a questa parte perdono produzione.
Di fronte alla rassegnazione di uno sviluppo senza occupazione, quali soluzioni si prospettano? Secondo Bertinotti, bisogna prendere il lavoro che c’è e dividerlo per tre; secondo altri quello che conta è produrre, si tratta poi di distribuire il reddito prodotto mantenendo anche chi non ha lavoro. Sono soluzioni sbagliate perché è sbagliato il modo di affrontare il problema: non si riflette sul fatto che mai la tecnologia ha distrutto il lavoro, perché se la tecnologia da una parte distrugge il lavoro, dall’altra apre la possibilità di fare altri lavori. Inoltre si pensa che i bisogni dell’uomo siano dati, mentre invece non è così: il bisogno dell’uomo non è come quello dei castori e delle api, è un bisogno plastico, che prende forma continuamente di fronte alle possibilità. L’uomo ha sempre avuto bisogno di mangiare, ma ha inventato mille modi per mangiare; l’uomo ha sempre avuto bisogno di muoversi, ma ha inventato mille modi per muoversi; l’uomo ha sempre avuto bisogno di comunicare, ma ha inventato mille modi per comunicare... quindi la tecnologia, che rende possibile produrre ciò che si produceva prima con meno lavoro, rende possibile anche dare nuove risposte ai nuovi bisogni.
In realtà, si tratta di come si concepisce l’uomo, se secondo una concezione religiosa che vede l’uomo aperto all’infinito – e un uomo aperto all’infinito è un uomo che sa che non c’è mai la risposta definitiva ai suoi bisogni –, o se secondo una visione atea che vede l’uomo come un elenco di bisogni dati, una volta soddisfatti i quali può sentirsi a posto. Non a caso questa era la previsione di Marx: nel socialismo realizzato, Marx prevede che gli uomini non lavorino più proprio perché la tecnologia riesce a produrre per tutti quello che prima era necessario produrre col lavoro. Liberato dai condizionamenti della proprietà privata, l’uomo non avrà più bisogno di lavorare e tutti avranno secondo il loro bisogno. La profezia è sbagliata perché è sbagliata la concezione del bisogno che ci sta dietro, concezione che non è solo di Marx ma di quasi tutti gli economisti, anche quelli anti-marxisti come Keynes.
Se si concepisce l’uomo come assetato dell’infinito, non ci si rassegna alla disoccupazione, perché si sa che il bisogno da soddisfare è senza fine, nella duplice dimensione del bisogno personale e del bisogno di 5 miliardi di uomini. La tecnologia invece di impiegare 250 persone per verniciare ne impiega una sola: meno male, perché questo significa che le altre 249 possono fare qualche altra cosa. Il problema è che se le nostre istituzioni non sono in grado di favorire un cambiamento rapido per quei 249, l’unica soluzione è di offrire loro il sussidio della disoccupazione. E purtroppo il nostro sistema si è organizzato così: si limita a dare un po’ di soldi ai disoccupati per sopravvivere – indennità di disoccupazione, cassa integrazione, prepensionamento. Ma questo non è più sostenibile, perché ci sono sempre meno soldi e perché il numero di licenziati aumenta sempre di più. E la gente arriva così a pensare che meno bambini nascono meglio è... I nostri giovani assorbono questa idea, che è il nichilismo applicato ad un problema economico. Bisogna assolutamente combattere questo modo di pensare. Come?
Innanzitutto con un’analisi seria che faccia capire che tutto ciò non è necessario; diventa inevitabile se il sistema non mette la gente in condizione di organizzarsi per dare nuove risposte a nuovi bisogni rapidamente, se corporativisticamente si pensa di difendere i lavoratori difendendo dei posti che non ci sono. Inoltre – e spieghiamo anche il titolo di questo nostro incontro – la disoccupazione è abbinata alla opportunità, perché, in tutta la sua drammaticità, il momento della disoccupazione può diventare positivo se si mettono in campo iniziative che utilizzino i soldi che sono a disposizione (anziché distribuire sussidi!) o se si mettono le persone in condizione di riacquistare mezzi e quindi fiducia.
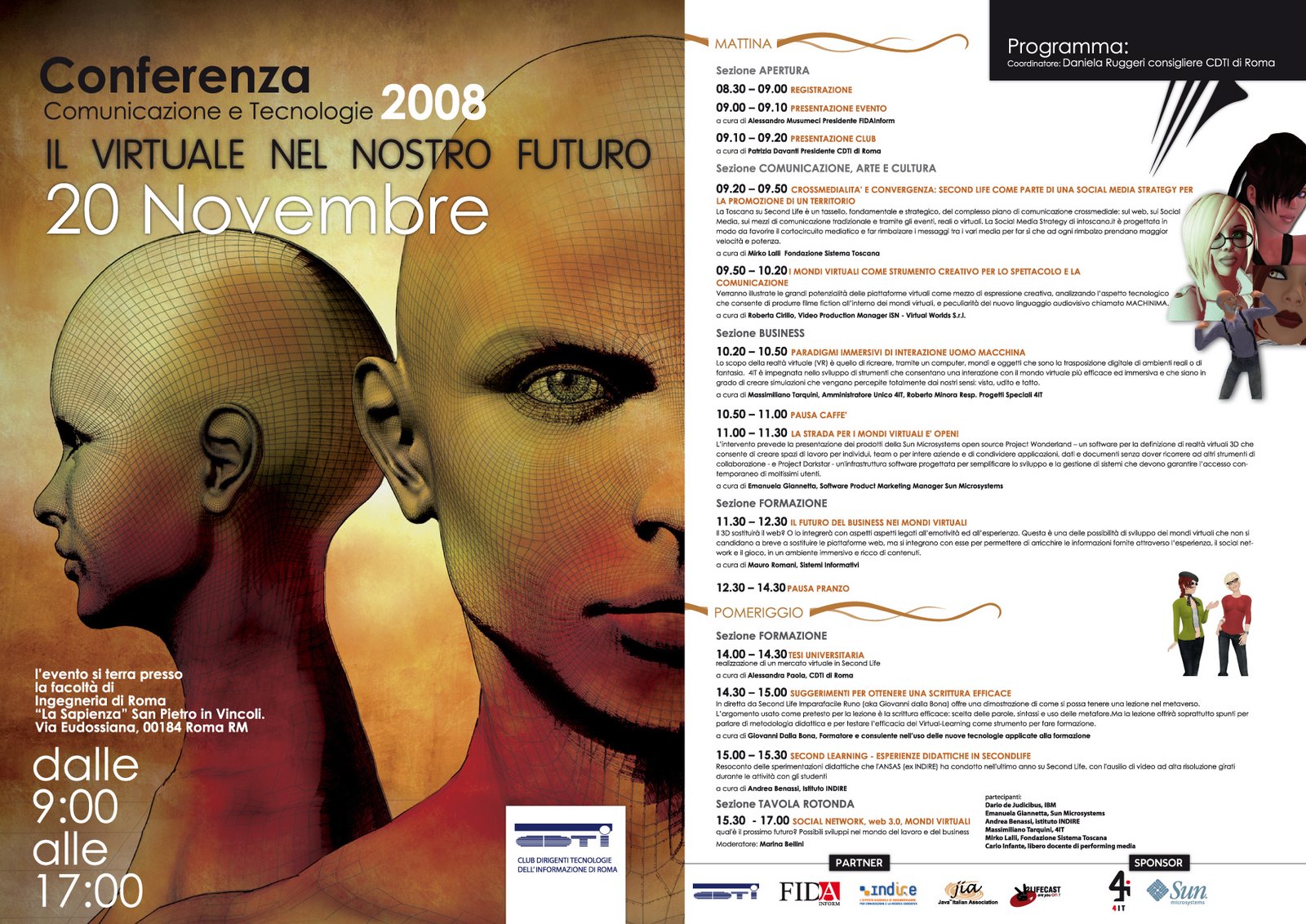 Un’ultima notazione. In una situazione di questo genere la formazione è una condizione essenziale, perché chi fa più fatica oggi non sono i laureati e i diplomati, ma chi non ha nessun titolo di studio. Più basso è il livello di formazione, più difficile è la riconversione della persona; riconvertirsi infatti vuol dire imparare rapidamente una cosa che non si sapeva fare, e impara più rapidamente chi ha una formazione di base che chi non l’ha. Quindi bisogna accentuare la formazione, che implica due aspetti: c’è una formazione di base, che vuol dire acquisire i linguaggi comuni, la capacità di ragionare, di leggere, di scrivere... E poi c’è la formazione che specializza, che permette di acquisire le categorie fondamentali di una materia. È inutile inseguire la specializzazione dell’ultima novità, perché l’ultima novità quando viene insegnata è già vecchia rispetto al mondo produttivo... la formazione deve invece mettere in grado di cogliere la novità.
Un’ultima notazione. In una situazione di questo genere la formazione è una condizione essenziale, perché chi fa più fatica oggi non sono i laureati e i diplomati, ma chi non ha nessun titolo di studio. Più basso è il livello di formazione, più difficile è la riconversione della persona; riconvertirsi infatti vuol dire imparare rapidamente una cosa che non si sapeva fare, e impara più rapidamente chi ha una formazione di base che chi non l’ha. Quindi bisogna accentuare la formazione, che implica due aspetti: c’è una formazione di base, che vuol dire acquisire i linguaggi comuni, la capacità di ragionare, di leggere, di scrivere... E poi c’è la formazione che specializza, che permette di acquisire le categorie fondamentali di una materia. È inutile inseguire la specializzazione dell’ultima novità, perché l’ultima novità quando viene insegnata è già vecchia rispetto al mondo produttivo... la formazione deve invece mettere in grado di cogliere la novità.Gerardi: Presenterò una proposta – pubblicata sul Corriere delle Opere, nel numero di luglio e agosto – che riguarda un piano integrato di formazione lavoro, la cui peculiarità è quella non solo di formare e mettere in attività lavorativa la gente, ma anche di dare una possibilità di permanere in attività più a lungo se le condizioni esterne non permettono di assorbire il personale: di conseguenza è una proposta che si addice particolarmente a situazioni di emergenza occupazionale. È chiaro che ormai in tutta Europa il problema è gravissimo, specialmente dove manchino autentici rapporti di solidarietà. In questo contesto economico, solo soluzioni come quelle di cui hanno parlato i miei colleghi possono avere un risultato concreto. Bisogna escogitare qualcosa fuori dalla norma, come appunto la proposta di cui parlerò.
Il percorso logico che porta a questa proposta è il seguente: siamo in un ambiente economico ostile, quindi dobbiamo cercare di costruire una struttura che dipenda il meno possibile da esso. In casi estremi, su chi possiamo contare? Sui membri stessi del nostro gruppo che lavora, quindi occorre ampliare la gamma di produzione a tutto l’arco del consumo familiare, e far aumentare notevolmente le possibilità di autoconsumo. L’autoconsumo è la chiave: naturalmente, lo scopo della nostra proposta non è costruire comunità di sopravvivenza o di autosostentamento... quello che ci interessa è creare una struttura di formazione nell’ambito dell’attività lavorativa, non in aule ma direttamente.
Il sistema che proponiamo prevede una gamma di produzione e di conseguenza una gamma di formazione. Si può avere una possibilità di rotazione, da una unità produttiva all’altra, e si realizza così questo sistema che sta in piedi da sé, questo centro che produrrà beni e servizi di consumo finale. Essendo una produzione di consumo finale, avrà bisogno di finanziarsi per acquistare il consumo intermedio: l’export sul mercato è difficile, quindi la liquidità per l’acquisto del consumo intermedio proverrà dai lavori socialmente utili che saranno dati in appalto a questo sistema attraverso le varie leggi esistenti. Come fase successiva, si dovranno cercare quelle nicchie di mercato sia di beni che di servizi sui quali si potrà lentamente far sfogare la produzione, senza creare fenomeni di concorrenza sleale. Queste nicchie di mercato sono i luoghi in cui la domanda è parzialmente solvibile, e in cui le imprese non hanno un sufficiente osservatorio per potersi installare: comuni montani, zone che vengono spopolate... bisogna cercare di rivitalizzarli, e attraverso questo sistema vi è proprio la possibilità di recuperare liquidità e quindi di creare una seconda parte della remunerazione.
Si tratta dunque di una struttura minima che permette di formare e di mettere in attività, dando un reddito di base che permetta di partire e di aprirsi a ulteriori possibilità. Questa realtà è un esperimento pilota, che vorremo realizzare nei pressi di Palermo, nel comune di Villabate, cercando di rodare questa procedura sul piano economico: se funzionasse, data la natura piuttosto standard di questa realtà, si potrebbe tentare di fonderla con altri sistemi.
Sintesi del libro bianco Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva di Édith Cresson 1995
orso castano : la piramidalizzazione delle istituzioni pubbliche, la governance quasi esclusivamente politica, l'assenza di qualsiasi collegamento serio tra le strutture produttive e l'insegnamento , la negazione dello spazio di liberta' individuale nell'accrescimento delle conoscenze , l'uso burocratico e strumentale politico nella gestione della cosa pubblica, stanno portando ad un disastro economico non da poco. Uno Stato protervio, malamente politicizzato, culi di pietra dappertutto, in qualsiasi posto di potere per quanto piccolo, culi di pietra agganciati , anzi incollati alle poltrone, con ferocia impediscono qualsiasi liberalizzazione della cultura e soffocano sul nascere qualsiasi sviluppo creativo. Riusciranno i nuovi governi a seguire le linee guida del libro bianco europeo? Ne dubitiamo fortemente, ma la speranza e' l'ultima a morire. Vedremo cosa sapra' fare questo nuovo parlamento , se sapra' spazzare via la rigidita' montiana per sostituirla con vere liberalizzazioni, oppure se riempira' di chiacchiere il suo agire per lasciarci finire in un bel burrone!!
...........................................Verso la società conoscitiva, link
 Il libro bianco parte da una constatazione: le mutazioni in corso hanno incrementato le possibilità di ciascun individuo di accedere all'informazione ed al sapere. Al tempo stesso questi fenomeni comportano una modifica delle competenze necessarie e dei sistemi di lavoro che necessitano di notevoli adattamenti.
Il libro bianco parte da una constatazione: le mutazioni in corso hanno incrementato le possibilità di ciascun individuo di accedere all'informazione ed al sapere. Al tempo stesso questi fenomeni comportano una modifica delle competenze necessarie e dei sistemi di lavoro che necessitano di notevoli adattamenti.Per tutti questa evoluzione ha significato più incertezza. Per alcuni si è venuta a creare una situazione di emarginazione intollerabile. Sempre più la posizione di ciascuno di noi nella società verrà determinata dalle conoscenze che avrà acquisito. La società del futuro sarà quindi una società che saprà investire nell'intelligenza, una società in cui si insegna e si apprende, in cui ciascun individuo può costruire la propria qualifica.
In altri termini, una società conoscitiva.
I tre fattori di cambiamento
Fra i numerosi e complessi mutamenti che travagliano la società europea, tre grandi tendenze, tre grandi sono particolarmente percettibili: si tratta dell'estensione a livello mondiale degli scambi, dell'avvento della società dell'informazione e del rapido progresso della rivoluzione scientifica e tecnica.
La società dell'informazione: la sua conseguenza principale è quella di trasformare le caratteristiche del lavoro e l'organizzazione della produzione. Lavori di routine e ripetitivi, lavori cui era destinata la maggior parte dei lavoratori dipendenti, vanno scomparendo a vantaggio di un'attività più autonoma più variata. Il risultato è un diverso rapporto nell'impresa. Il ruolo del fattore umano assume più importanza, ma nel tempo stesso il lavoratore è più vulnerabile rispetto ai cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, perché è diventato un semplice individuo confrontato ad una rete complessa. Sorge quindi la necessità per tutti di adattarsi non solo ai nuovi strumenti tecnici, ma anche alla trasformazione delle condizioni di lavoro.
L'estensione a livello mondiale degli scambi: questo fattore sconvolge i dati sulla creazione di posti di lavoro. Dopo un primo momento in cui ha interessato soltanto lo scambio di merci, di tecnologia e gli scambi finanziari , l'estensione degli scambi a livello mondiale cancella le frontiere fra i mercati del lavoro, a un punto tale che il mercato globale dell'occupazione è una prospettiva più vicina di quanto non si creda. Nel libro bianco "Crescita, competitività, occupazione ", la Commissione ha chiaramente accolto la sfida dell'apertura mondiale, sottolineando al tempo stesso l'importanza di mantenere il livello sociale Europeo, il che comporterà un miglioramento generale delle qualifiche, altrimenti l'onere sociale rischia di essere tale da diffondere fra i cittadini una sensazione di insicurezza.
La civiltà scientifica e tecnica: lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, la loro applicazione ai metodi di produzione, i prodotti sempre più sofisticati che sono il risultato di questa applicazione danno origine ad un paradosso: malgrado un effetto generalmente benefico, il progresso scientifico e tecnico fa sorgere nella società un sentimento di minaccia, addirittura una paura irrazionale. Ne consegue la tendenza a conservare della scienza soltanto un'immagine violenta e preoccupante. Numerosi paesi Europei hanno cominciato a reagire a questa situazione di disagio: promuovendo la cultura scientifica e tecnica sin dai banchi di scuola; definendo regole etiche , in particolare nei settori della biotecnologia e delle tecnologie dell'informazione; ovvero ancora favorendo il dialogo fra gli scienziati e i responsabili politici, se necessario tramite istituzioni create appositamente.
La società dell'informazione: la sua conseguenza principale è quella di trasformare le caratteristiche del lavoro e l'organizzazione della produzione. Lavori di routine e ripetitivi, lavori cui era destinata la maggior parte dei lavoratori dipendenti, vanno scomparendo a vantaggio di un'attività più autonoma più variata. Il risultato è un diverso rapporto nell'impresa. Il ruolo del fattore umano assume più importanza, ma nel tempo stesso il lavoratore è più vulnerabile rispetto ai cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, perché è diventato un semplice individuo confrontato ad una rete complessa. Sorge quindi la necessità per tutti di adattarsi non solo ai nuovi strumenti tecnici, ma anche alla trasformazione delle condizioni di lavoro.
L'estensione a livello mondiale degli scambi: questo fattore sconvolge i dati sulla creazione di posti di lavoro. Dopo un primo momento in cui ha interessato soltanto lo scambio di merci, di tecnologia e gli scambi finanziari , l'estensione degli scambi a livello mondiale cancella le frontiere fra i mercati del lavoro, a un punto tale che il mercato globale dell'occupazione è una prospettiva più vicina di quanto non si creda. Nel libro bianco "Crescita, competitività, occupazione ", la Commissione ha chiaramente accolto la sfida dell'apertura mondiale, sottolineando al tempo stesso l'importanza di mantenere il livello sociale Europeo, il che comporterà un miglioramento generale delle qualifiche, altrimenti l'onere sociale rischia di essere tale da diffondere fra i cittadini una sensazione di insicurezza.
La civiltà scientifica e tecnica: lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, la loro applicazione ai metodi di produzione, i prodotti sempre più sofisticati che sono il risultato di questa applicazione danno origine ad un paradosso: malgrado un effetto generalmente benefico, il progresso scientifico e tecnico fa sorgere nella società un sentimento di minaccia, addirittura una paura irrazionale. Ne consegue la tendenza a conservare della scienza soltanto un'immagine violenta e preoccupante. Numerosi paesi Europei hanno cominciato a reagire a questa situazione di disagio: promuovendo la cultura scientifica e tecnica sin dai banchi di scuola; definendo regole etiche , in particolare nei settori della biotecnologia e delle tecnologie dell'informazione; ovvero ancora favorendo il dialogo fra gli scienziati e i responsabili politici, se necessario tramite istituzioni create appositamente.
Le risposte: cultura generale e attitudine all'occupazione
Quali sono le risposte che possono fornire l'istruzione e la formazione per eliminare gli effetti nocivi previsti causati da questi tre fattori ? Il libro bianco propone due risposte
a) rivalutare la cultura generale
La prima risposta consiste nella rivalutazione della cultura generale. In una società in cui l'individuo dovrà essere in grado di comprendere situazioni complesse che evolvono in modo imprevedibile, in cui dovrà affrontare un cumulo di informazioni di ogni genere, esiste un rischio di separazione fra coloro che possono interpretare, coloro che possono utilizzare e coloro che non possono fare né l'una né l'altra cosa. In altri termini, tra coloro che sanno e coloro che non sanno. Lo sviluppo della cultura generale, cioè della capacità di cogliere il significato delle cose, di capire e di creare, è la funzione di base della scuola, nonché l primo fattore di adattamento all'economia e all'occupazione.
Inoltre si osserva sempre più un ritorno della cultura generale nei centri di formazione professionale, nei programmi di riconversione dei lavoratori con poche qualifiche o molto specializzati; essa diventa un passaggio obbligato verso l'acquisizione di nuove competenze tecniche.
La prima risposta consiste nella rivalutazione della cultura generale. In una società in cui l'individuo dovrà essere in grado di comprendere situazioni complesse che evolvono in modo imprevedibile, in cui dovrà affrontare un cumulo di informazioni di ogni genere, esiste un rischio di separazione fra coloro che possono interpretare, coloro che possono utilizzare e coloro che non possono fare né l'una né l'altra cosa. In altri termini, tra coloro che sanno e coloro che non sanno. Lo sviluppo della cultura generale, cioè della capacità di cogliere il significato delle cose, di capire e di creare, è la funzione di base della scuola, nonché l primo fattore di adattamento all'economia e all'occupazione.
Inoltre si osserva sempre più un ritorno della cultura generale nei centri di formazione professionale, nei programmi di riconversione dei lavoratori con poche qualifiche o molto specializzati; essa diventa un passaggio obbligato verso l'acquisizione di nuove competenze tecniche.
b) sviluppare l'attitudine all'occupazione
Secondo orientamento: sviluppare l'attitudine all'occupazione. In che modo l'istruzione e la formazione possono aiutare i paesi Europei a creare occupazioni durevoli, in quantità paragonabile ai posti di lavoro scomparsi a causa delle nuove tecnologie?
Il sistema tradizionale, quello che generalmente segue l'individuo, è la conquista del titolo di studio. Ne risulta una tendenza generale, a livello Europeo, di prolungare gli studi e una forte pressione sociale per ampliare l'accesso agli studi superiori. Il diploma resta ancora oggi il miglior passaporto per l'occupazione, il fenomeno tuttavia ha un rovescio della medaglia: una svalutazione dei settori professionali, ritenuti opzioni di seconda categoria; una sovraqualificazione dei giovani, rispetto alle occupazioni che vengono proposte loro quando entrano nella vita attiva; infine un'immagine del diploma come riferimento quasi assoluto di competenza, che permette di filtrare le élite al vertice e, più generalmente, di classificare i lavoratori in una determinata occupazione. Da questo deriva una maggiore rigidità del mercato del lavoro e un enorme spreco dovuto all'eliminazione di persone dotate di talento, ma che non corrispondono al profilo standard.
Senza rimettere in questione questa via tradizionale in quanto tale, il libro bianco suggerisce di associarvi un'impostazione di tipo più aperto, più flessibile. Essa consiste in particolare nell'incoraggiare la mobilità dei lavoratori.- dipendenti, insegnanti, ricercatori - e degli studenti. Al giorno d'oggi sorprende dover constatare che in Europa le merci, i capitali, e i servizi circolano più liberamente delle persone e delle conoscenze.
Tuttavia perché questa mobilità venga veramente attuata bisogna passare da un riconoscimento delle conoscenze acquisite all'interno dell'Unione Europea: non solo per quanto riguarda i diplomi, ma anche per le varie materie che li compongono. In altri termini, uno studente che abbia effettuato un semestre di studio in un altro paese europeo dovrebbe ottenere automaticamente il riconoscimento dall'università di origine, senza dover ripetere gli esami corrispondenti.
Attualmente questo è possibile solo se le due università interessate hanno già stipulato un accordo fra loro. Una vera mobilità comporta l'eliminazione degli ostacoli amministrativi e giuridici (legati al diritto di soggiorno e al regime di protezione sociale), oppure fiscali (imposizione delle borse di studio).
Un'altra idea - impulso: l'accesso alla formazione deve essere sviluppato nell'arco di tutta la vita.
Visto che tutti, autorità o imprese, ne sottolineano la necessità, i progressi compiuti in questo senso sono molto scarsi. Nell'Unione Europea, un lavoratore dipendente beneficia mediamente di una settimana di formazione continua su un periodo di tre anni. Questo è tanto più insufficiente se si tiene conto dei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, imputabili in particolare a questi nuovi strumenti, e ha un carattere urgente.
L'Anno Europeo 1996, dedicato all'istruzione e alla formazione nell'arco di tutta la vita , deve aiutarci a prendere coscienza di questa esigenza.
Ma la società dell'informazione non modifica soltanto il funzionamento dell'impresa. Essa offre nuovi orizzonti per l'istruzione e le formazione, ma bisogna essere attrezzati per sfruttare pienamente questo potenziale. Orbene, la frammentazione del mercato europeo del settore multimediale, la qualità ancora scarsa dei prodotti multimediali disponibili, la scarsa disponibilità di elaboratori nelle classi (1 ogni 30 alunni in Europa, 1 ogni 10 alunni negli Stati Uniti) hanno come conseguenza una penetrazione molto lenta di questi strumenti nelle scuole. Per questo motivo la Commissione attribuisce priorità allo sviluppo di software multimediale per l'istruzione coordinando ancor più gli sforzi di ricerca compiuti in questa direzione dall'Unione Europea. Peraltro è questo il compito affidato ad una " task force " che raggruppa le risorse della sig.ra Cresson e del sig Bangemann.
Secondo orientamento: sviluppare l'attitudine all'occupazione. In che modo l'istruzione e la formazione possono aiutare i paesi Europei a creare occupazioni durevoli, in quantità paragonabile ai posti di lavoro scomparsi a causa delle nuove tecnologie?
Il sistema tradizionale, quello che generalmente segue l'individuo, è la conquista del titolo di studio. Ne risulta una tendenza generale, a livello Europeo, di prolungare gli studi e una forte pressione sociale per ampliare l'accesso agli studi superiori. Il diploma resta ancora oggi il miglior passaporto per l'occupazione, il fenomeno tuttavia ha un rovescio della medaglia: una svalutazione dei settori professionali, ritenuti opzioni di seconda categoria; una sovraqualificazione dei giovani, rispetto alle occupazioni che vengono proposte loro quando entrano nella vita attiva; infine un'immagine del diploma come riferimento quasi assoluto di competenza, che permette di filtrare le élite al vertice e, più generalmente, di classificare i lavoratori in una determinata occupazione. Da questo deriva una maggiore rigidità del mercato del lavoro e un enorme spreco dovuto all'eliminazione di persone dotate di talento, ma che non corrispondono al profilo standard.
Senza rimettere in questione questa via tradizionale in quanto tale, il libro bianco suggerisce di associarvi un'impostazione di tipo più aperto, più flessibile. Essa consiste in particolare nell'incoraggiare la mobilità dei lavoratori.- dipendenti, insegnanti, ricercatori - e degli studenti. Al giorno d'oggi sorprende dover constatare che in Europa le merci, i capitali, e i servizi circolano più liberamente delle persone e delle conoscenze.
Tuttavia perché questa mobilità venga veramente attuata bisogna passare da un riconoscimento delle conoscenze acquisite all'interno dell'Unione Europea: non solo per quanto riguarda i diplomi, ma anche per le varie materie che li compongono. In altri termini, uno studente che abbia effettuato un semestre di studio in un altro paese europeo dovrebbe ottenere automaticamente il riconoscimento dall'università di origine, senza dover ripetere gli esami corrispondenti.
Attualmente questo è possibile solo se le due università interessate hanno già stipulato un accordo fra loro. Una vera mobilità comporta l'eliminazione degli ostacoli amministrativi e giuridici (legati al diritto di soggiorno e al regime di protezione sociale), oppure fiscali (imposizione delle borse di studio).
Un'altra idea - impulso: l'accesso alla formazione deve essere sviluppato nell'arco di tutta la vita.
Visto che tutti, autorità o imprese, ne sottolineano la necessità, i progressi compiuti in questo senso sono molto scarsi. Nell'Unione Europea, un lavoratore dipendente beneficia mediamente di una settimana di formazione continua su un periodo di tre anni. Questo è tanto più insufficiente se si tiene conto dei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, imputabili in particolare a questi nuovi strumenti, e ha un carattere urgente.
L'Anno Europeo 1996, dedicato all'istruzione e alla formazione nell'arco di tutta la vita , deve aiutarci a prendere coscienza di questa esigenza.
Ma la società dell'informazione non modifica soltanto il funzionamento dell'impresa. Essa offre nuovi orizzonti per l'istruzione e le formazione, ma bisogna essere attrezzati per sfruttare pienamente questo potenziale. Orbene, la frammentazione del mercato europeo del settore multimediale, la qualità ancora scarsa dei prodotti multimediali disponibili, la scarsa disponibilità di elaboratori nelle classi (1 ogni 30 alunni in Europa, 1 ogni 10 alunni negli Stati Uniti) hanno come conseguenza una penetrazione molto lenta di questi strumenti nelle scuole. Per questo motivo la Commissione attribuisce priorità allo sviluppo di software multimediale per l'istruzione coordinando ancor più gli sforzi di ricerca compiuti in questa direzione dall'Unione Europea. Peraltro è questo il compito affidato ad una " task force " che raggruppa le risorse della sig.ra Cresson e del sig Bangemann.
Mobilità, formazione continua, ricorso ai nuovi strumenti tecnologici
Questa maggiore flessibilità nell'acquisire conoscenze ci invita a riflettere sui nuovi modi per il riconoscimento delle competenze acquisite, sia che siano sancite da un diploma , che in caso contrario. Questa impostazione è già stata messa in pratica: il TOEFL, che consente di valutare le conoscenze della lingua inglese di chiunque, i test "canguro " per la matematica sono dispositivi che hanno dimostrato la loro validità.
A questo punto perché non immaginare una "tessera personale delle competenze" sulla quale figurerebbero le conoscenze del titolare, che siano di base (lingue, matematica, diritto, informatica, economia, ecc....) o tecniche, ovvero addirittura professionali (contabilità , tecnica finanziaria ..... )? In questo modo un giovane non munito di diploma potrebbe candidarsi ad un posto di lavoro munito della tessera sulla quale figurerebbero le sue competenze per quanto riguarda l'espressione scritta, le conoscenze linguistiche, il trattamento testi.
Tale formula permetterebbe di valutare istantaneamente le qualifiche di ognuno in ogni momento della propria vita, contrariamente ai diplomi che, nel corso degli anni - e sempre più rapidamente - perdono il loro valore.
A questo punto perché non immaginare una "tessera personale delle competenze" sulla quale figurerebbero le conoscenze del titolare, che siano di base (lingue, matematica, diritto, informatica, economia, ecc....) o tecniche, ovvero addirittura professionali (contabilità , tecnica finanziaria ..... )? In questo modo un giovane non munito di diploma potrebbe candidarsi ad un posto di lavoro munito della tessera sulla quale figurerebbero le sue competenze per quanto riguarda l'espressione scritta, le conoscenze linguistiche, il trattamento testi.
Tale formula permetterebbe di valutare istantaneamente le qualifiche di ognuno in ogni momento della propria vita, contrariamente ai diplomi che, nel corso degli anni - e sempre più rapidamente - perdono il loro valore.
Orientamenti per l'azione
La costruzione della società cognitiva non sarà oggetto di un decreto, ma sarà un processo continuo. Questo libro bianco non ha l'ambizione di presentare un programma di provvedimenti, la Commissione non propone toccasana. Essa intende soltanto proporre una riflessione e tracciare linee d'azione. Senza in alcun modo volersi sostituire alle responsabilità nazionali, il libro bianco suggerisce che vengano raggiunti cinque obiettivi generali per un'azione e per ciascuno di loro, uno o più progetti di sostegno svolti a livello comunitario.
1) Favorire l'acquisizione di nuove conoscenze: in altre parole, innalzare il livello generale delle conoscenze. In questa prospettiva, la Commissione invita anzitutto a riflettere su nuovi sistemi di riconoscimento delle competenze che non sono necessariamente sancite da un diploma. A livello Europeo il libro Bianco propone un nuovo sistema di riconoscimento delle competenze tecniche e professionali.
Come attuare questa impostazione? Anzitutto creando delle reti Europee di centri di ricerca e di centri di formazione professionale, di imprese, di settori professionali che permetteranno di identificare le conoscenze più richieste, le competenze indispensabili. Si tratterà quindi di definire i metodi migliori di riconoscimento (test, programmi di valutazione, addetti alla valutazione...). Alla fine il risultato potrebbe essere una tessera personale delle competenze che permetterebbe a chiunque di far riconoscere le proprie conoscenze e competenze in tutta l'Unione Europea.
Il Libro bianco vuole inoltre facilitare la mobilità degli studenti. La Commissione proporrà di autorizzare uno studente che abbia ottenuto una borsa di studio nel proprio paese a utilizzarla, qualora lo desideri, per seguire dei corsi in un istituto superiore di un altro Stato membro. Essa proporrà inoltre di diffondere il riconoscimento reciproco delle " unità di valore " dell'insegnamento (sistema ECTS - Sistema di trasferimento di crediti accademici ), vale a dire delle varie conoscenze di cui è composto il diploma. Infine la Commissione proporrà di eliminare gli ostacoli amministrativi, giuridici e relativi alla protezione sociale che frenano gli scambi di studenti, di partecipanti a corsi di formazione, insegnanti e ricercatori. Infine verranno pubblicati bandi di gara comuni ai vari programmi comunitari che si interessano allo sviluppo di materiale didattico informatizzato multimediale.
Come attuare questa impostazione? Anzitutto creando delle reti Europee di centri di ricerca e di centri di formazione professionale, di imprese, di settori professionali che permetteranno di identificare le conoscenze più richieste, le competenze indispensabili. Si tratterà quindi di definire i metodi migliori di riconoscimento (test, programmi di valutazione, addetti alla valutazione...). Alla fine il risultato potrebbe essere una tessera personale delle competenze che permetterebbe a chiunque di far riconoscere le proprie conoscenze e competenze in tutta l'Unione Europea.
Il Libro bianco vuole inoltre facilitare la mobilità degli studenti. La Commissione proporrà di autorizzare uno studente che abbia ottenuto una borsa di studio nel proprio paese a utilizzarla, qualora lo desideri, per seguire dei corsi in un istituto superiore di un altro Stato membro. Essa proporrà inoltre di diffondere il riconoscimento reciproco delle " unità di valore " dell'insegnamento (sistema ECTS - Sistema di trasferimento di crediti accademici ), vale a dire delle varie conoscenze di cui è composto il diploma. Infine la Commissione proporrà di eliminare gli ostacoli amministrativi, giuridici e relativi alla protezione sociale che frenano gli scambi di studenti, di partecipanti a corsi di formazione, insegnanti e ricercatori. Infine verranno pubblicati bandi di gara comuni ai vari programmi comunitari che si interessano allo sviluppo di materiale didattico informatizzato multimediale.
2) Avvicinare la scuola e l'impresa: sviluppare l'apprendimento in Europa sotto tutti gli aspetti; il libro bianco propone di collegare tramite una rete i centri di apprendimento dei vari paesi Europei, favorire la mobilità degli apprendisti nel quadro di un programma del tipo ERASMUS e mettere a punto uno statuto Europeo dell'apprendista, facendo seguito al prossimo libro verde sugli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in corso di formazione.
3) Lottare contro l'emarginazione: offrire una seconda opportunità tramite la scuola. I giovani esclusi dal sistema scolastico sono a volte decine di migliaia nei grandi agglomerati urbani. Sempre più le scuole che si trovano in quei quartieri particolarmente sensibili vengono riorientate verso dispositivi che offrano una seconda opportunità. Si tratta per queste scuole di migliorare l'accesso alle conoscenze facendo ricorso a migliori insegnanti, pagati meglio che altrove, nonché a ritmi di insegnamento adattati, a tirocini nelle aziende, disponibilità di materiale multimediale, classi composte da un numero ridotto di alunni,. Inoltre la scuola deve svolgere il ruolo di centro d'animazione del contesto in cui crollano i riferimenti sociali e familiari. Come fare? Il libro bianco propone di sviluppare i finanziamenti complementari Europei, a partire da programmi esistenti quali i programmi Socrates o Leonardo, appoggiando i finanziamenti nazionali e regionali. Si suggerisce anche di sviluppare la concertazione e il partenariato con il settore economico: si potrebbe ad esempio, immaginare che ogni impresa sponsorizzi una scuola, eventualmente con promessa di assunzione qualora il riconoscimento delle competenze sia soddisfacente. Le famiglie sarebbero anch'esse coinvolte direttamente nel funzionamento del dispositivo di formazione. Infine, il ricorso a nuovi metodi pedagogici, tecnologie dell'informazione e tecnologie multimediali verrebbe fortemente incoraggiato
4) Possedere Tre lingue comunitarie: un marchio di qualità. La conoscenza di più lingue è diventata oggi una condizione indispensabile per ottenere un lavoro e questo è ancor più necessario in un mercato Europeo senza frontiere. Inoltre costituisce un vantaggio che permette di comunicare più facilmente con gli altri, scoprire culture e mentalità diverse, stimolare l'intelletto. Il plurilinguismo, elemento di' identità e caratteristica della cittadinanza Europea, è inoltre un elemento di base della società conoscitiva. Pertanto il libro bianco propone di istituire un marchio di qualità "classi Europee ", che verrebbe attribuito, in base ad un certo numero di criteri, alle scuole che abbiano sviluppato meglio l'apprendimento delle lingue. Gli istituti che otterranno questo marchio saranno collegati fra di loro mediante una rete. Peraltro verrebbe sistematicamente favorita la mobilità dei professori di lingua materna verso gli istituti di altri paesi.
5) Trattare sullo stesso piano l'investimento a livello fisico e l'investimento a livello di formazione. Non basta portare l'istruzione e la formazione a livello di priorità per la competitività e l'occupazione. Bisogna inoltre incoraggiare, grazie a provvedimenti concreti, le imprese o le autorità pubbliche che hanno compiuto grandi sforzi a favore di questo investimento " non materiale ", a proseguire sulla stessa strada. Ciò comporta, in particolare, un evoluzione del trattamento fiscale e contabile delle spese destinate alla formazione. Sarebbe quindi auspicabile che venissero adottate disposizioni a favore delle imprese che attribuiscono particolare attenzione alla formazione, affinché una parte degli stanziamenti impegnati a questo scopo vengano iscritti in bilancio all'attivo, come beni non patrimoniali. Parallelamente dovrebbero essere sviluppate formule del tipo "risparmio formazione ", destinate a persone che desiderino rinnovare le loro conoscenze o riprendere una formazione dopo aver interrotto gli studi.
Queste raccomandazioni non hanno la pretesa di risolvere l'insieme delle questioni sospese. Il libro bianco ha un obiettivo più modesto: contribuire, tramite le politiche dell'istruzione e della formazione degli Stati Membri, a orientare l'Europa sulla strada della società cognitiva. Esso intende inoltre avviare, nel corso dei prossimi anni, un dibattito più vasto, poiché sononecessarie trasformazioni profonde. Come ha dichiarato la sig.ra Cresson, "i sistemi d'istruzione e di formazione hanno troppo spesso l'effetto di tracciare una volta per tutte il percorso professionale. C'è troppa rigidità , troppi ostacoli tra i sistemi d'istruzione e di formazione, manca la comunicazione, mancano le possibilità di ricorrere a nuovi tipi di insegnamento nell'arco di tutta la vita".
Il libro bianco può contribuire a dimostrare che, per garantire il futuro dell'Europa e il suo posto nel mondo, occorre attribuire un'attenzione prioritaria allo sviluppo personale dei suoi cittadini, un'attenzione almeno pari a quella accordata finora alle questioni economiche e monetarie. In questo modo l'Europa dimostrerà che non è soltanto una semplice zona di libero scambio, ma un insieme politico organizzato, in grado, non già di subire, ma di controllare l'espansione a livello mondiale.
Il libro bianco può contribuire a dimostrare che, per garantire il futuro dell'Europa e il suo posto nel mondo, occorre attribuire un'attenzione prioritaria allo sviluppo personale dei suoi cittadini, un'attenzione almeno pari a quella accordata finora alle questioni economiche e monetarie. In questo modo l'Europa dimostrerà che non è soltanto una semplice zona di libero scambio, ma un insieme politico organizzato, in grado, non già di subire, ma di controllare l'espansione a livello mondiale.
Conclusioni generali
Il mondo attraversa un periodo di transizione e di profondi cambiamenti. Tutto indica che la società europea, al pari delle altre, sta per entrare in una nuova era, probabilmente più mutevole ed imprevedibile delle precedenti.
Certo, questa nuova era della mondializzazione degli scambi, della società dell'informazione, degli sconvolgimenti scientifici e tecnici suscita interrogativi e timori soprattutto perché non è agevole precisarne i contorni.
Questi interrogativi e timori sono probabilmente più forti in Europa che altrove. La civiltà Europea è antica e complessa. Essa è oggi divisa fra una sete di ricerca e di conoscenza molto forte, eredità di una storia che ha visto l'Europa compiere la prima rivoluzione tecnica industriale e cambiare così il mondo, e una fortissima domanda di stabilità e di sicurezza collettiva. Questa aspirazione è perfettamente comprensibile in un continente così a lungo devastato dalle guerre e dilaniato dai conflitti politici e sociali, ma può andare fino ad alimentare riflessi conservatori nei riguardi del cambiamento.
Eppure, questa epoca di trasformazioni è opportunità storica per l'Europa perché tali periodi di mutamenti, in cui una società genera quella che le succederà, sono i soli propizi a profonde riforme che permettono di evitare bruschi cambiamenti. L'incremento degli scambi attraverso il mondo, le scoperte scientifiche, le nuove tecnologie aprono di fatto nuove potenzialità di sviluppo e di progresso.
Leggiamo quanto scrive un grande storico europeo per comparare questo periodo di mutazioni con quelli precedenti, in particolare il periodo del passaggio dal Medioevo al Rinascimento:
Certo, questa nuova era della mondializzazione degli scambi, della società dell'informazione, degli sconvolgimenti scientifici e tecnici suscita interrogativi e timori soprattutto perché non è agevole precisarne i contorni.
Questi interrogativi e timori sono probabilmente più forti in Europa che altrove. La civiltà Europea è antica e complessa. Essa è oggi divisa fra una sete di ricerca e di conoscenza molto forte, eredità di una storia che ha visto l'Europa compiere la prima rivoluzione tecnica industriale e cambiare così il mondo, e una fortissima domanda di stabilità e di sicurezza collettiva. Questa aspirazione è perfettamente comprensibile in un continente così a lungo devastato dalle guerre e dilaniato dai conflitti politici e sociali, ma può andare fino ad alimentare riflessi conservatori nei riguardi del cambiamento.
Eppure, questa epoca di trasformazioni è opportunità storica per l'Europa perché tali periodi di mutamenti, in cui una società genera quella che le succederà, sono i soli propizi a profonde riforme che permettono di evitare bruschi cambiamenti. L'incremento degli scambi attraverso il mondo, le scoperte scientifiche, le nuove tecnologie aprono di fatto nuove potenzialità di sviluppo e di progresso.
Leggiamo quanto scrive un grande storico europeo per comparare questo periodo di mutazioni con quelli precedenti, in particolare il periodo del passaggio dal Medioevo al Rinascimento:
"L'Europa del Medioevo e dei tempi moderni ha dovuto far fronte al mondo bizantino, al mondo arabo, all'impero turco. Oggi si tratta per fortuna di un confronto più pacifico; ma l'esistenza dei protagonisti della storia giganteschi per estensione o per la forza economica, o per entrambe nello stesso tempo, impone all'Europa di raggiungere una dimensione paragonabile alla loro se vuole esistere, evolversi e conservare la sua identità. Di fronte all'America, al Giappone, domani alla Cina, l'Europa deve avere la massa economica, demografica e politica capace di garantire la sua indipendenza.
Essa ha per fortuna dalla sua la forza della sua civiltà e dei suoi patrimoni comuni. L'abbiamo visto nel corso di venticinque secoli, in strati sempre rinnovati, la civiltà Europea è stata creatrice; e ancora oggi, come dice lo slogan, la principale materia prima dell'Europa è probabilmente la materia grigia."
(Jacques le Goff, La vecchia Europa e la nostra, Parigi, 1994)
E' proprio sulla dimensione Europea che potrà essere edificata una società di progresso capace nello stesso tempo di contribuire a modificare la natura delle cose su scala planetaria e preservare una piena coscienza di sé.
Il presente libro bianco ha difeso il punto di vista secondo il quale è costruendo il più rapidamente possibile la società conoscitiva Europea che tale obiettivo potrà essere raggiunto.
Questo passo in avanti comporta trasformazioni profonde. I sistemi d'istruzione e di formazione hanno infatti troppo spesso l'effetto di tracciare una volta per tutte gli iter professionali Esistono troppe rigidità troppe barriere fra i sistemi di istruzione e di formazione, non abbastanza vi sono interconnessioni, possibilità di cogliere nuovi metodi d'insegnamento nell'arco di tutta la vita.
L'istruzione e la formazione trasmettono i capisaldi necessari all'affermazione di qualsivoglia identità collettiva, consentendo nel contempo nuovi progressi scientifici e tecnologici. L'autonomia conferita agli individui, se condivisa da tutti, consolida il senso della coesione e radica il sentimento di appartenenza. La diversità culturale dell'Europa, la sua antichità, la mobilità fra culture diverse sono grandissime opportunità di adattamento al nuovo mondo che si profila all'orizzonte.
Essere europei significa beneficiare di conquiste culturali di una varietà e di una profondità ineguagliate. Deve peraltro anche comportare la possibilità di beneficiare di tutte le opportunità di accesso al sapere e alla competenza. Lo scopo del libro bianco è quello di permettere un maggiore sfruttamento di tali possibilità; le raccomandazioni che vi figurano non possono pretendere di esaurire l'argomento.
Esse hanno un obiettivo più modesto: contribuire con le politiche dell'istruzione e della formazione degli Stati membri a collocare l'Europa sul cammino della società conoscitiva. Esse mirano inoltre ad avviare nei prossimi anni un dibattito più vasto. Possono contribuire infine a mostrare che l'avvenire dell'Europa e il suo posto nel mondo dipendono dalla capacità di conferire oggi all'evoluzione delle donne e degli uomini che la compongono un ruolo almeno altrettanto grande di quello attribuito finora agli aspetti economici e monetari. In questo modo l'Europa potrà mostrare di non essere una semplice zona di libero scambio, ma un complesso politico organizzato, nonché uno strumento idoneo a padroneggiare, e non già a subire, la mondializzazione.
Il presente libro bianco ha difeso il punto di vista secondo il quale è costruendo il più rapidamente possibile la società conoscitiva Europea che tale obiettivo potrà essere raggiunto.
Questo passo in avanti comporta trasformazioni profonde. I sistemi d'istruzione e di formazione hanno infatti troppo spesso l'effetto di tracciare una volta per tutte gli iter professionali Esistono troppe rigidità troppe barriere fra i sistemi di istruzione e di formazione, non abbastanza vi sono interconnessioni, possibilità di cogliere nuovi metodi d'insegnamento nell'arco di tutta la vita.
L'istruzione e la formazione trasmettono i capisaldi necessari all'affermazione di qualsivoglia identità collettiva, consentendo nel contempo nuovi progressi scientifici e tecnologici. L'autonomia conferita agli individui, se condivisa da tutti, consolida il senso della coesione e radica il sentimento di appartenenza. La diversità culturale dell'Europa, la sua antichità, la mobilità fra culture diverse sono grandissime opportunità di adattamento al nuovo mondo che si profila all'orizzonte.
Essere europei significa beneficiare di conquiste culturali di una varietà e di una profondità ineguagliate. Deve peraltro anche comportare la possibilità di beneficiare di tutte le opportunità di accesso al sapere e alla competenza. Lo scopo del libro bianco è quello di permettere un maggiore sfruttamento di tali possibilità; le raccomandazioni che vi figurano non possono pretendere di esaurire l'argomento.
Esse hanno un obiettivo più modesto: contribuire con le politiche dell'istruzione e della formazione degli Stati membri a collocare l'Europa sul cammino della società conoscitiva. Esse mirano inoltre ad avviare nei prossimi anni un dibattito più vasto. Possono contribuire infine a mostrare che l'avvenire dell'Europa e il suo posto nel mondo dipendono dalla capacità di conferire oggi all'evoluzione delle donne e degli uomini che la compongono un ruolo almeno altrettanto grande di quello attribuito finora agli aspetti economici e monetari. In questo modo l'Europa potrà mostrare di non essere una semplice zona di libero scambio, ma un complesso politico organizzato, nonché uno strumento idoneo a padroneggiare, e non già a subire, la mondializzazione.
Coldiretti, per la metà delle famiglie italiane il 2013 sarà più difficile


da 
ROMA - Per il 48 per cento delle famiglie italiane la situazione economica è destinata a peggiorare nel 2013, per il 42 per cento rimarrà la stessa mentre perappena il 10 per cento migliorerà. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Swg sulle prospettive
economiche delle famiglie italiane nel 2013.L'ottimismo degli analisti economici con la discesa dello spread non sembra trovare riscontro nelle famiglie, che nel 51 per cento dei casi dichiarano già adesso di riuscire a pagare appena le spese senza potersi permettere ulteriori lussi, mentre una percentuale dell'8 per cento non ha un reddito sufficiente nemmeno per l'indispensabile.
C'è però anche un 40 per cento di italiani che vive serenamente senza particolari affanni economici e l'1 per cento che si può concedere dei lussi. La maggioranza delle famiglie nonostante i saldi ricicla dall'armadio gli abiti smessi nel cambio stagione, con il 53 per cento degli italiani che ha rinunciato o rimandato gli acquisti di abbigliamento ed accessori, che si classificano come i prodotti dei quali si fa maggiormente a meno nel tempo della crisi.
Sul podio delle rinunce insieme ai vestiti si collocano anche i viaggi e le vacanze che sono stati ridotti o annullati dal 51 per cento degli italiani e la frequentazione di bar, discoteche o ristoranti nel tempo libero, dei quali ha fatto a meno ben il 48 per cento.
A seguire nella classifica del cambiamento delle abitudini di consumo c'è l'acquisto di nuove tecnologie al quale hanno dovuto dire addio il 42 per cento degli italiani, le ristrutturazioni della casa (40 per cento), l'auto o la moto nuova (38 per cento) e gli arredamenti (38 per cento), ma anche le attività culturali (37 per cento) la cui rinuncia preoccupa particolarmente in un Paese che deve trovare via alternative per uscire dalla crisi.
Da segnalare sul lato opposto il fatto che - sostiene la Coldiretti - solo il 17 per cento degli italiani dichiara di aver ridotto la spesa o rimandato gli acquisti alimentari, una percentuale superiore solo alle spese per i figli (9 per cento). «È necessario rompere questa spirale negativa aumentando il reddito disponibile soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione», ha affermato il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare «la necessità di sostenere la ripresa dei consumi per rilanciare l'economia».
Usa: Obama ai Repubblicani, ''Basta giochi pericolosi sull'economia''
orso castano: il nuovo governo, quando "verra'" , dovra' misurarsi proprio con i problemi che sta affrontando ora Obama. C'e' la fara'? , Non sappiamo. E' uno scontro di ideologie ed interessi economici. E' chiaro che questo scontro al Centro del potere dove Wall Street impera , sul mondo, e' duro. Ai Repubblicani importa solo mantenere i privilegi dei piu' ricchi. La novita' positiva sono la globalizzazione e la possibilita' di diffondere le informazioni attraverso internet.
da 
05 Gennaio 2013 - 13:22
(ASCA-AFP) - Washington, 5 gen - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha avvertito i membri del Congresso repubblicani che non e' piu' possibile quello che ha definito il ''gioco pericoloso'' con l'economia del paese, menre i parlamentari si preparano a una nuova battaglia per la definizione del tetto sul debito. ''Se il Congresso impedisce di dare agli Usa la possibilita' di pagare il suo debito in tempo, le conseguenze per l'intera economia globale potrebbero essere disastrose'', ha detto il presidente, nel consueto discorso settimanale via radio e via web. ''Le nostre famiglie e i nostri affari non possono permettersi nuovamente questo gioco pericoloso''.
Gli Stati Uniti hanno raggiunto il limite dei 16 mila e 400 miliardi. Il Congresso ha ora circa due mesi di tempo per alzare il tetto del debito per consentire al governo di chiedere nuovi prestiti per evitare il default finanziario.
Gli Stati Uniti hanno raggiunto il limite dei 16 mila e 400 miliardi. Il Congresso ha ora circa due mesi di tempo per alzare il tetto del debito per consentire al governo di chiedere nuovi prestiti per evitare il default finanziario.
martedì 1 gennaio 2013
True Progressivism
da The Economist
orso castano: niente male le proposte dell'economist che hanno il pregio della chiarezzza ; un'istruziiìone estesa , di libero accesso e super aggiornata e diminuzione attraverso le tasse del divario ricchi/poveri. Speriamo che Bersani anche da noi abbia questo coraggio. Lo aspettiamo al varco!


BY THE end of the 19th century, the first age of globalisation and a spate of new inventions had transformed the world economy. But the “Gilded Age” was also a famously unequal one, with America’s robber barons and Europe’s “Downton Abbey” classes amassing huge wealth: the concept of “conspicuous consumption” dates back to 1899. The rising gap between rich and poor (and the fear of socialist revolution) spawned a wave of reforms, from Theodore Roosevelt’s trust-busting to Lloyd George’s People’s Budget. Governments promoted competition, introduced progressive taxation and wove the first threads of a social safety net. The aim of this new “Progressive era”, as it was known in America, was to make society fairer without reducing its entrepreneurial vim.
orso castano: niente male le proposte dell'economist che hanno il pregio della chiarezzza ; un'istruziiìone estesa , di libero accesso e super aggiornata e diminuzione attraverso le tasse del divario ricchi/poveri. Speriamo che Bersani anche da noi abbia questo coraggio. Lo aspettiamo al varco!
Inequality and the world economy
A new form of radical centrist politics is needed to tackle inequality without hurting economic growth
Oct 13th 2012 | from the print edition


BY THE end of the 19th century, the first age of globalisation and a spate of new inventions had transformed the world economy. But the “Gilded Age” was also a famously unequal one, with America’s robber barons and Europe’s “Downton Abbey” classes amassing huge wealth: the concept of “conspicuous consumption” dates back to 1899. The rising gap between rich and poor (and the fear of socialist revolution) spawned a wave of reforms, from Theodore Roosevelt’s trust-busting to Lloyd George’s People’s Budget. Governments promoted competition, introduced progressive taxation and wove the first threads of a social safety net. The aim of this new “Progressive era”, as it was known in America, was to make society fairer without reducing its entrepreneurial vim.
Modern politics needs to undergo a similar reinvention—to come up with ways of mitigating inequality without hurting economic growth. That dilemma is already at the centre of political debate, but it mostly produces heat, not light. Thus, on America’s campaign trail, the left attacks Mitt Romney as a robber baron and the right derides Barack Obama as a class warrior. In some European countries politicians have simply given in to the mob: witness François Hollande’s proposed 75% income-tax rate. In much of the emerging world leaders would rather sweep the issue of inequality under the carpet: witness China’s nervous embarrassment about the excesses of Ferrari-driving princelings, or India’s refusal to tackle corruption.
Does inequality really need to be tackled? The twin forces of globalisation and technical innovation have actually narrowed inequality globally, as poorer countries catch up with richer ones. But within many countries income gaps have widened. More than two-thirds of the world’s people live in countries where income disparities have risen since 1980, often to a startling degree. In America the share of national income going to the top 0.01% (some 16,000 families) has risen from just over 1% in 1980 to almost 5% now—an even bigger slice than the top 0.01% got in the Gilded Age.At the core, there is a failure of ideas. The right is still not convinced that inequality matters. The left’s default position is to raise income-tax rates for the wealthy and to increase spending still further—unwise when sluggish economies need to attract entrepreneurs and when governments, already far bigger than Roosevelt or Lloyd George could have imagined, are overburdened with promises of future largesse. A far more dramatic rethink is needed: call it True Progressivism.
To have or to have not
To have or to have not
It is also true that some measure of inequality is good for an economy. It sharpens incentives to work hard and take risks; it rewards the talented innovators who drive economic progress. Free-traders have always accepted that the more global a market, the greater the rewards will be for the winners. But as our special report this week argues, inequality has reached a stage where it can be inefficient and bad for growth.
That is most obvious in the emerging world. In China credit is siphoned to state-owned enterprises and well-connected insiders; the elite also gain from a string of monopolies. In Russia the oligarchs’ wealth has even less to do with entrepreneurialism. In India, too often, the same is true.
In the rich world the cronyism is better-hidden. One reason why Wall Street accounts for a disproportionate share of the wealthy is the implicit subsidy given to too-big-to-fail banks. From doctors to lawyers, many high-paying professions are full of unnecessary restrictive practices. And then there is the most unfair transfer of all—misdirected welfare spending. Social spending is often less about helping the poor than giving goodies to the relatively wealthy. In America the housing subsidy to the richest fifth (through mortgage-interest relief) is four times the amount spent on public housing for the poorest fifth.
Even the sort of inequality produced by meritocracy can hurt growth. If income gaps get wide enough, they can lead to less equality of opportunity, especially in education. Social mobility in America, contrary to conventional wisdom, is lower than in most European countries. The gap in test scores between rich and poor American children is roughly 30-40% wider than it was 25 years ago. And by some measures class mobility is even stickier in China than in America.
Some of those at the top of the pile will remain sceptical that inequality is a problem in itself. But even they have an interest in mitigating it, for if it continues to rise, momentum for change will build and may lead to a political outcome that serves nobody’s interests. Communism may be past reviving, but there are plenty of other bad ideas out there.
Hence the need for a True Progressive agenda. Here is our suggestion, which steals ideas from both left and right to tackle inequality in three ways that do not harm growth.
Compete, target and reform
The priority should be a Rooseveltian attack on monopolies and vested interests, be they state-owned enterprises in China or big banks on Wall Street. The emerging world, in particular, needs to introduce greater transparency in government contracts and effective anti-trust law. It is no coincidence that the world’s richest man, Carlos Slim, made his money in Mexican telecoms, an industry where competitive pressures were low and prices were sky-high. In the rich world there is also plenty of opening up to do. Only a fraction of the European Union’s economy is a genuine single market. School reform and introducing choice is crucial: no Wall Street financier has done as much damage to American social mobility as the teachers’ unions have. Getting rid of distortions, such as labour laws in Europe or the remnants of China’s hukou system of household registration, would also make a huge difference.
Next, target government spending on the poor and the young. In the emerging world too much cash goes to universal fuel subsidies that disproportionately favour the wealthy (in Asia) and unaffordable pensions that favour the relatively affluent (in Latin America). But the biggest target for reform is the welfare states of the rich world. Given their ageing societies, governments cannot hope to spend less on the elderly, but they can reduce the pace of increase—for instance, by raising retirement ages more dramatically and means-testing the goodies on offer. Some of the cash could go into education. The first Progressive era led to the introduction of publicly financed secondary schools; this time round the target should be pre-school education, as well as more retraining for the jobless.
Last, reform taxes: not to punish the rich but to raise money more efficiently and progressively. In poorer economies, where tax avoidance is rife, the focus should be on lower rates and better enforcement. In rich ones the main gains should come from eliminating deductions that particularly benefit the wealthy (such as America’s mortgage-interest deduction); narrowing the gap between tax rates on wages and capital income; and relying more on efficient taxes that are paid disproportionately by the rich, such as some property taxes.
Different parts of this agenda are already being embraced in different countries. Latin America has invested in schools and pioneered conditional cash transfers for the very poor; it is the only region where inequality in most countries has been falling. India and Indonesia are considering scaling back fuel subsidies. More generally, as they build their welfare states, Asian countries are determined to avoid the West’s extravagance. In the rich world Scandinavia is the most inventive region. Sweden has overhauled its admittedly huge welfare state and has a universal school-voucher system. Britain too is reforming schools and simplifying welfare. In America Mr Romney says he wants to means-test Medicare and cut tax deductions, though he is short on details. Meanwhile, Mr Obama, a Democrat, has invoked Theodore Roosevelt, and Ed Miliband, leader of Britain’s Labour Party, is now trying to wrap himself in Benjamin Disraeli’s “One Nation” Tory cloak.
Such cross-dressing is a sign of change, but politicians have a long way to go. The right’s instinct is too often to make government smaller, rather than better. The supposedly egalitarian left’s failure is more fundamental. Across the rich world, welfare states are running out of money, growth is slowing and inequality is rising—and yet the left’s only answer is higher tax rates on wealth-creators. Messrs Obama, Miliband and Hollande need to come up with something that promises both fairness and progress. Otherwise, everyone will pay.
Iscriviti a:
Post (Atom)


