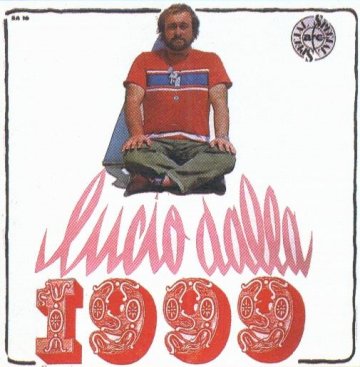Consulta promuove legge veneta su specializzandi Medicina da
Consulta promuove legge veneta su specializzandi Medicina da 
Venezia 16 mag. (Adnkronos Salute) - Le legge regionale del Veneto che ha istituito i contratti regionali di formazione specialistica, finanziando una novantina di borse di studio aggiuntive per gli specializzandi in Medicina, non lede le prerogative statali in materia di istruzione, professioni e tutela della salute, né i principi di libera circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro titoli. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 126 del 7 maggio scorso (ma notificata solo ieri in Regione), che ha così respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo."Una grande vittoria per il Veneto, che vede riconosciuto il diritto all'autonomia e il principio che le risorse dei veneti rimangano in Veneto a beneficio dei bisogni della propria comunità", commenta Leonardo Padrin (Forza Italia), presidente della Commissione Sanità e 'padre' della legge 9 approvata dal Consiglio veneto con voto unanime il 3 maggio 2013. "I giudici della suprema Corte - ha affermato Padrin, nel corso della conferenza stampa indetta presso la direzione dell'azienda ospedaliera di Padova, presente il direttore generale Claudio Dario - hanno riconosciuto il pieno diritto della Regione ad esercitare la propria autonomia nel destinare proprie risorse a borse di studio aggiuntive per i futuri medici, in modo da integrare l'esiguo numero dei posti di specialità riconosciuti dal ministero".
Obiettivo della legge 9 del maggio scorso è quello di garantire la formazione specialistica dei medici che si laureano negli atenei veneti di Padova e Verona, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria delle due università ed assicurare così la presenza di specialisti nelle strutture e negli enti del Servizio sanitario regionale. La legge prevede che la Regione individui ogni tre anni il fabbisogno dei medici specialisti da formare, tenendo conto della propria programmazione sanitaria e della situazione occupazionale. La Giunta regionale è delegata a predisporre i bandi, e potrà anche prevedere particolari norme che impegnino i borsisti a rimanere a lavorare in Veneto, una volta specializzati. Complessivamente la legge ha stanziato 27 milioni di euro nel triennio 2013-2015 per finanziare 92 borse di studio regionali che andranno ad integrare il numero dei contratti di formazione ministeriali (circa 400) concessi alle scuole di specialità di medicina in Veneto.
Nel luglio scorso il Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge veneta davanti ai giudici della Consulta, ritenendola "invasiva" della potestà esclusiva dello Stato in materia di contratti di formazione, lesiva delle norme in materia di libera circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro diplomi e "anticostituzionale" perché avrebbe violato la potestà statale in materia di professioni e tutela della salute. Inoltre - contestava il governo - l'istituzione di contratti di formazione aggiuntivi avrebbe creato una disparità di trattamento tra gli specializzandi a contratto della Regione Veneto e quelli assoggettati al contratto nazionale. Le valutazioni dei giudici della Corte Costituzionale sono state invece di opposto avviso e hanno considerato "generiche" e "infondate" le censure del governo."E' la stessa normativa statale - spiega la sentenza della Consulta - a lasciare aperto uno spazio di intervento per il legislatore regionale in materia di contratti di formazione specialistica dei medici", visto che il decreto ministeriale che fissa il numero di posti da assegnare a ogni scuola di specializzazione prevede anche che le singole Regioni possano attivare e finanziare borse di studio aggiuntive. Né l'eventuale clausola che riserva alla Giunta veneta la possibilità di aggiungere ai contratti di formazione regionale specifiche condizioni (come la richiesta che i neo-specializzati rimangano per un certo periodo a lavorare nelle strutture sanitarie della regione) modifica, secondo la Corte Costituzionale, lo schema tipo del contratto disciplinato dallo Stato. "Fermo restando – avverte la Corte - che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale".