L'intervento di Carlo di Valois e l'esilio dei bianchi [modifica]
Il principe francese si trovava a Firenze dal
1 novembre 1301, in una visita di cortesia mascherata, che generava molta inquietudine nei fiorentini. Vi era entrato in pompa magna, con cavalli e fanti di picche, con l'intento ufficiale di riportare la pace tra le fazioni in lotta, e giurando solennemente di non arrecare danno alla città e alle sue istituzioni per nessuna ragione. Molti sono gli aneddoti che riporta il Compagni, come quello secondo il quale Carlo invitò i priori presso la sua residenza nelle case dei
Frescobaldi: essi tuttavia ebbero sospetto e solo tre andarono
[5], i quali, una volta lì, si resero conto loro malgrado di non essere desiderati e che l'invito era stato forse solo un maldestro tentativo di imprigionarli tutti.
Il Valois iniziò tuttavia a promulgare leggi dure e richiese il pagamento di tributi per la sovvenzione della sua milizia. Egli aveva inoltre provveduto a nominare alla suprema magistratura fiorentina, quella di
podestà,
Cante Gabrielli da
Gubbio, uomo fedele alla Chiesa ed ai disegni politici di Bonifacio VIII (
9 novembre 1301).
La progressiva occupazione del potere fece sì che non ci furono reazioni quando i Donati iniziarono a rientrare in città alla spicciolata, non solo violando la disposizione dell'esilio, ma dandosi a saccheggi, omicidi e altre efferatezze. Carlo di Valois si risolse anche all'utilizzo di stratagemmi, con lo scopo di eliminare gli elementi a lui ostili, come in occasione della scoperta di un documento che avrebbe provato l'esistenza di una congiura contro la sua persona (
1302). Questo documento, tuttora esistente nell'Archivio di Stato, è rappresentato da un atto notarile stipulato tra i
Cerchi, i
Gherardini e la
Repubblica di Siena: tuttavia non è mai stato chiarito se si trattasse di un originale o di una messinscena architettata dai neri, come piuttosto sembrerebbe. Fatto sta, che quella fu la scusa anche per sradicare dal contado le ultime frange della nobiltà signorile e di fatto, con la distruzione del castello di
Montagliari, finì l'epoca feudale in Toscana.
All'ottobre
1302 il potere era ormai in mano ai neri che si erano insediati in tutti gli uffici governativi con l'appoggio del papa e del Valois. Al
30 giugno 1302, termine della sua podesteria, Cante Gabrielli si era reso responsabile di 170 condanne a morte ed dell'espulsione di circa seicento cittadini della fazione dei bianchi.
Avvicinamento tra guelfi bianchi e ghibellini [modifica]
La cacciata da Firenze, con l'esperienza dell'esilio ed i tentativi di rientrare in città con la forza, spinse i guelfi bianchi a cercare l'appoggio del partito
ghibellino, come prova ad esempio la battaglia (
1303) presso
Castel Puliciano, che vide i fuoriusciti fiorentini uniti ai ghibellini di
Scarpetta Ordelaffi, signore di
Forlì, presso cui Dante si era rifugiato, quell'anno, ricevendone la qualifica di segretario. Ecco come introduce l'episodio
Dino Compagni: «La terza disaventura ebbono i Bianchi e Ghibellini (la quale gli accomunò, e i due nomi si ridussono in uno) per questa cagione: che essendo
Folcieri da Calvoli podestà di Firenze, i Bianchi chiamorono Scarpetta degli Ordalaffi loro capitano, uomo giovane e temperato, nimico di Folcieri».
I due, in effetti, erano già avversari in patria, a
Forlì, dove prevalse il partito degli
Ordelaffi. Ma, nella battaglia in questione, il vincitore fu Fulcieri.
La nascita di conflitti era favorita anche da un sistema giudiziario facilmente corruttibile e sprovvisto di solide leggi con le quali dirimere le controversie.
Dino Compagni racconta di vari episodi che avevano come colpevole
Corso Donati e il suo clan, ma attraverso la corruzione dei giudici essi riuscivano sempre a farla franca
[4].............
 il suo concetto d'infinito assoluto che identificò con Dio. Egli scrisse:
il suo concetto d'infinito assoluto che identificò con Dio. Egli scrisse: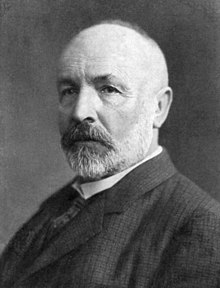 Cantor diede origine alla teoria degli insiemi (1874-1884).[3] Fu il primo a capire che gli insiemi infiniti possono avere diverse grandezze: dapprima mostrò che dato un qualsiasi insieme
Cantor diede origine alla teoria degli insiemi (1874-1884).[3] Fu il primo a capire che gli insiemi infiniti possono avere diverse grandezze: dapprima mostrò che dato un qualsiasi insieme  , esiste l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di
, esiste l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di  , chiamato l'insieme potenza di
, chiamato l'insieme potenza di  . Poi dimostrò che l'insieme potenza di un insieme infinito
. Poi dimostrò che l'insieme potenza di un insieme infinito  ha una grandezza maggiore della grandezza di
ha una grandezza maggiore della grandezza di  stesso (questo fatto è oggi noto con il nome di teorema di Cantor). Dunque esiste una gerarchia infinita di grandezze di insiemi infiniti, dalla quale sorgono i numeri cardinali e ordinali transfiniti, e la loro peculiare aritmetica. Per denotare i numeri cardinali usò la lettera dell'alfabeto ebraico aleph dotata di un numero naturale come indice (
stesso (questo fatto è oggi noto con il nome di teorema di Cantor). Dunque esiste una gerarchia infinita di grandezze di insiemi infiniti, dalla quale sorgono i numeri cardinali e ordinali transfiniti, e la loro peculiare aritmetica. Per denotare i numeri cardinali usò la lettera dell'alfabeto ebraico aleph dotata di un numero naturale come indice ( Alef zero); per gli ordinali utilizzò la lettera dell'alfabeto grecoomega.
Alef zero); per gli ordinali utilizzò la lettera dell'alfabeto grecoomega.





 .
.